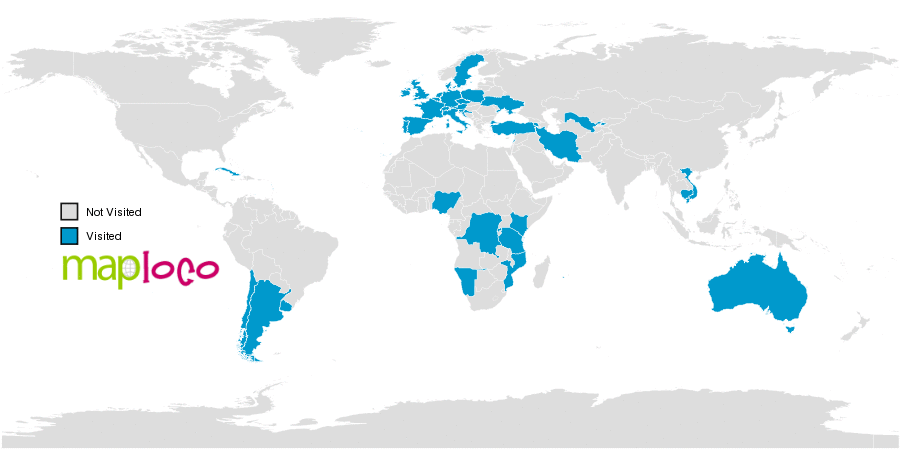Irresistibilmente Iran – Immagini dall’Ashura
L’Ashura è forse (parere di un neofita) la celebrazione più iconica e fondamentale dell’Islam shiita e, di conseguenza, dell’Iran – di cui è religione di Stato. Religione di Stato, in uno Stato dichiaratamente teocratico.
Si tratta della ricorrenza della battaglia di Karbala, durante la quale venne ucciso il nipote del profeta Maometto, Ali. Se non erro, la divisione fra i seguaci di Ali e non è all’origine dello scisma fra sunniti e shiiti.
Le celebrazioni in Iran sono al limite dell’affare di Stato, con diverse comunità che si mobilitano nelle settimane e giorni precedenti la ricorrenza listando a lutto palazzi ed edifici vari e erigendo stands neri dai quali offrono bevande fresche in quelli che (oggi) sono i giorni più caldi dell’anno.
Vista l’importanza fondativa e ufficiale, il limite fra rimembranza e lutto spontanei e cerimonie ufficiali diventa piuttosto labile: tante imprese fanno sfoggio di bandiere nere e poster che invitano alla penitenza e le enormi bandiere dell’Iran che generalmente si vedono qua e là nella capitale sono in questi giorni sostituite da altrettanto enormi bandiere nere.
In questo senso, la ricorrenza dell’Ashura ricorda un pò le commemorazioni a ricordo del genocidio in Ruanda.
Ma il massimo della triste celebrazione si ha nel giorno della ricorrenza stessa, quando diverse colonne di credenti inscenano situazioni luttuose che ricordano gli eventi della battaglia: c’è chi dà fuoco alle tende, ci inscena combattimenti di spade, chi si avvia in processione auto-flagellandosi.
L’intera scena appare più mitigata rispetto a qualche tempo fa, quando i credenti arrivavano a tagliarsi veramente la fronte e far grondare sangue nella disperazione. Poi le autorità sono intervenute e hanno cominciato a porre alcune restrizioni sugli atti più violenti e sanguinari: oggi le auto-flagellazioni sono fatte con fruste dotate di catenite assai leggere, giusto sufficienti all’effetto scenico.
La processione ricorda, visivamente e concettualmente, alcune celebrazioni delle sagre per i santi patroni che si vedono tuttura in Italia, specie al sud.
Simili sono le espressioni di partecipazione (dolore) popolare, simili sono i sentimenti di passione, simili sono le rappresentazioni dove la passione si fonde talmente con manierismo da apparire al limite del kitsch agli occhi di uno spettatore ignaro.
Ma l’aspetto più interessante, nella mia limitata esperienza, è stato sicuramente osservare la partecipazione delle donne.
Queste celebrazioni sono generalmente inscenate dalle comunità più ferventemente religiose e conservative dell’Iran. Infatti a Teheran le più scenografiche sono quelle attorno alla zona del bazaar o nel sud della capitale, dove si concentrano le comunità più conservatrici (quelle che all’epoca avevano sostenuto in massa Ahmadinejad, per fare un esempio). Per questa ragione, la partecipazione delle donne è estremamente limitata e le donne che si vedono sono generalmente fortemente velate – ad esempio nelle preghiere svoltesi in strada, indossavano un esteso chador nero, al quale più di qualcuna ha poi sovrapposto un ulteriore largo velo dai colori più chiari.
Personalmente, nella giornata passata a guardare le celebrazioni, ho visto al massimo 2-3 donne altrettante bambine accompagnate dai genitori. Quando ho raccontato questa curiosa visione ai colleghi iraniani, la loro generale risposta è stata: “Hai visto più donne partecipare di quante ne abbiamo viste noi negli ultimi dieci anni“.
Questo è forse uno dei paradossi più rappresentativi dell’Iran contemporaneo: le donne che oggi partecipano nelle ceremonie dell’Ashura sono fra le più conservatrici del paese; eppure al tempo stesso svolgono un ruolo quasi di avanguardia progressista, in questo caso nel ricavare uno spazio nuovo e altrimenti inaspettato per le donne.
Vota:
Irresistibilmente Iran / Contraddizioni
Dire che un paese è “fatto di contraddizioni” è sostanzialmente un luogo comune cui si ricorre per dire tutto e niente di quello stesso paese. Un modo elegante per ammettere che, in fondo, di quel paese ci abbiamo capito poco più di niente.
Vi risparmierò, dunque, questa montagna di banalità parlando dell’Iran.
Credo, piuttosto, sia utile offrire squarci di queste contraddizioni e lasciare a voi giudicare. Come sempre, tracciare un punto d’inizio di queste osservazioni (una immaginaria linea “start“) è praticamente impossibile, quindi ricorrerò semplicemente alla mia prima memoria.
Aeroporto di Vienna, area d’imbarco del volo per Teheran: svariati iraniani che tornano a casa, ora della preghiera: solo un ragazzino (13-15 anni al massimo) si inginocchia alcune volte in direzione della Mecca.
In aereo, la passeggiera che piange al momento del decollo, con le hostess che cercano di capire come aiutarla, e di nuovo all’atterraggio.
In aereo, pochi istanti prima dello sbarco all’aeroporto Imam Khomeini: tutte le passeggere che si mettono il velo. Alcune che si prendono tutto il tempo di truccarsi (rossetto, mascara e quant’altro), alcune che ne indossano uno leopardato, altre che ne mettono uno semplicemente nero.
Girando per un centro commerciale di Teheran: la prima canzone che si sente in sottofondo è “Another Brick in the Wall 2” dei Pink Floyd.
Le donne e il velo: già all’epoca del mio primo viaggio in Iran, nel 2019, il velo era quasi più “un optional” che una realtà. Perlopiù, allora, era portato in modo molto sciolto, molto indietro sulla testa e regolarmente cadeva e doveva essere ritirato su in modo “conforme” alle prescrizioni. Oggi, la sfida a questa norma è ancora più aperta ed evidente. All’aeroporto Imam Khomeini sono rimasto stupido dalla semplicità con cui tante donne, iraniane e straniere, semplicemente tenevano il foulard attorno al collo – ma il collega venuto a prendermi mi spievava trattarsi semplicemente di maggiore tolleranza in quel contesto.
Osservazione che ho dovuto ripensare poco dopo, girando per le strade di Teheran attorno all’alberto: tante, tantissime se pensiamo all’imposizione che dovrebbe esserci, donne e ragazze (veramente di ogni età) girano bellamente ignorando la prescrizione – a volte anche sotto il naso di poliziotti, che fino a qui non ho visto reagire.
I monarchici – cercando casa sono finito a visitare un complesso residenziale abitato “da vecchi monarchici” (così mi diceva il tizio dell’UN): sono ancora tanti, almeno a Teheran, i sostenitori della monarchia Pahlavi, non solo anziani e che controllano ancora parti importanti dell’economia e del settore immobiliare in città – luoghi dove almeno a parole, le autorità non ingeriscono più di tanto (es. le ragazze che giocano a pallavolo in cortile senza velo). Persino al mercatino dell’antiquariato del venerdì, tanti cimeli della dinastia Pahlavi fanno bella mostra di sé per nostalgici e curiosi.
Come per quella foto nei dintorini di Kashan, è inevitabile domandarsi sulla reale “presa” della rivoluzione.
Le fotografie, la memoria. Ovunque, a Teheran e in Iran più in generale, si trovano foto commemorative dei “martiri” morti durante la “Guerra Imposta” con l’Iraq negli anni ’80 e di tutti i cittadini Iraniani successivamente uccisi “nel compimento del loro dovere” (l’allegoria è voluta). Persino le squadre di recupero dei corpi dei martiri, ove morti loro stessi attraversando i campi minati che ancora resistono al confine, accedono agli onori e alla qualifica di “martiri”.
Gli stranieri, le enclaves e le eccezioni. Ai parties nelle ambasciate l’alcol è cosa comune. Ma questo ce lo si poteva aspettare: le ambasciate sono da sempre, per definizione, luoghi eccezionali cui le regole per “i comuni mortali” possono subire qualche eccezione. Quello che più stupisce è la facilità con cui l’alcol “tracima” da questi luoghi anche in mille e mille abitazioni private, sia di stranieri che di iraniani. Qualche collega scherzava che ha bevuto più qui che nelle sue missioni precedenti, forse non sarà così… ma sicuramente il nettare di bacco (o altre sue declinazioni) non sarà un problema.
Le sanzioni – personalmente, resto convinto che le sanzioni economiche, almeno le prime (quelle imposte subito dopo la rivoluzione e dopo l’occupazione dell’ambasciata americana) abbiano quasi “salvato” l’Iran: senza esse, l’industria locale sarebbe stata facile preda del capitalismo globale e ogni produzione sarebbe dipesa da decisioni prese altrove. Certo, quelle più recenti sono un’altra cosa. L’inflazione galoppa, al punto quasi di vanificare gli sforzi umanitari, e rende le condizioni di vita piuttosto difficili per molti, ivi compreso nell’accesso ai beni di prima necessità. Ma soprattutto, queste sanzioni stanno strangolando parti essenziali dell’economia e dei servizi di base: alcuni farmaci sono reperibili solo tramite l’intervento delle ambasciate, i software sono bloccati per anni e anni fino a che le case produttrici non ne autorizzano l’uso. Persino la produzione di tappeti, dicono, rischia di essere gravemente compromessa: fra alcuni anni, dicono, non se ne troveranno più perché ora la produzione è al minimo – a causa delle sanzioni. Idem per i documenti di identità: una collega raccontava che se dovesse perdere la carta d’identità, potrebbe non riceverne una nuova, in quanto il governo non è in grado di produrne.
Un capitolo a parte meritano le contraddizioni relative ai rifugiati afghani. Ma vista l’ampiezza che richiederebbe, meglio rinviare ad un apposito post.
Nel complesso, se dovessi fare un paragone (certamente un po’ “tirato”), direi che per lo più l’Iran visto così mi ricorda il Libano. Un paese molto moderno, potremmo quasi dire “occidentalizzato” nella sua rottura di certi schemi tipici dell’immaginario mediorientale, ma nel quale traspaiono ancora forti tratti di conservativismo – tipo le sporadiche donne in chador che occasionalmente is incontrano a Teheran.
E un paese immerso in una grave crisi economica, altro fattore che tende a contestare limiti e barriere.
Certo, occorre tenere a mente che – come tutte le megalopoli- Teheran è un mondo a parte rispetto ad ogni altro luogo dell’Iran e sicuramente rispetto alle province più rurali (di nuovo, il tema dell’estensione e della “presa” della rivoluzione).
Vota:
Irresistibilmente Iran – comeback chameleon
Capita assai di rado, nelle nostre vite, che i “sogni” si avverino. Capita ancor più di rado che quelli che esplicitamente definiamo dei “sogni” arrivino poi a materializzarsi (ma uno può avere sogni inesatti?). Forse esiste un’ineluttabile contraddizione fra la dimensione del sogno e quella della realtà che, nel momento stesso in cui categoriziamo qualcosa nell’uno o nell’altro mondo, inevitabilmente finisce per rendere il passaggio dall’uno all’altro estremamente difficile.
Forse proprio per questo, al realizzarsi di questi “sogni” ci sentiamo pervasi da un senso quasi inevitabile di gratitudine: perché, nonostante tutti gli sforzi che possiamo aver profuso per conseguirli, intimamente sappiamo che una parte importante di quel successo non dipendeva affatto da noi, anzi trascendeva il dominio delle nostre capacità per entrare in quella dimensione dell’imponderabile – quella del sogno, appunto. Quella dimensione dove per definizione “tutte le stelle debbono allinearsi” e se anche noi possiamo spingerne una o due al posto giusto, il resto dipende da fattori fuori dal nostro controllo.
Ma il quinto pensiero è il piu’ importante: è la conclusione di tutto.
Ed è il pensiero che sicuramente io in Iran voglio tornare. E vi tornerò.
Così mi dicevo mentre un aereo fra Teheran e Kyiv si staccava dal suolo e mi riconduceva in quella che in quei mesi era “casa” dopo circa una settimana in Iran, una settimana che già allora sembrava un mezzo miracolo, visti tutti gli ostacoli che paiono circondare ogni esperienza di viaggio in questa terra.
Chi avrebbe mai pensato, allora, che tornare a Teheran si sarebbe rivelato più facile che tornare a Kyiv davvero non saprei dirlo.
Eppure, quattro anni dopo, rieccoci qui. Quanti giri abbiamo fatto da allora e quanto poco ci siamo mossi.
Sono riatterrato in Iran. Anzi, sono ormai qui da quasi un mese – quattro volte il tempo che vi ho passato in precedenza, sebbene in questo tempo quadruplicato abbia visto forse un decimo di quello che avevo visto quattro anni fa. Almeno in termini di “quello che si dovrebbe vedere”.
Quattro settimane e non sono ancora uscito da Teheran. Anzi, a dirla tutta ogni volta che vorrò provare ad uscire sarà un misto di sfida e di miracolo burocratico.
Intanto, però, ho visto tante cose che si dovrebbe vedere in senso completamente diverso: quello che si dovrebbe vedere, e capire, per cercare di comprendere la realtà di questo paese e della sua gente. Ho visto, osservato, discusso e vissuto tanti piccoli dettagli come granelli di sabbia che i turisti presi nella loro corsa fra Persepoli, Isfahan e Torre Azadi non hanno il tempo e l’occhio per notare.
Ho visto le colleghe e le donne tutte nella loro quotidiana decisione se mettere il velo oppure no. Ho cominciato ad intravedere la bolla della comunità internazionale, la sua retorica vuota e la sua assurdità. Ho visto un sistema burocratico pervaso da logiche che neanche immaginiamo. Ho visto un museo d’arte contemporanea con il severo ritratto di Khomeini e quadri di Gauguin. Ho visto una realtà economica in bilico fra spiccare il volo e crollare nel baratro.
Proverò a rendervene conto nei prossimi post.
E ho “visto” 4,5 milioni di Afghani (o più, i numeri non sono affatto chiari), “generosamente ospitati” dal governo negli ultimi quarant’anni.
Già, perché (ecco il camaleonte) non sono qui come turista che entra ed esca dal paese: sono qui come humanitarian che conta di contribuire al benessere di quegli afghani – fra gli ultimi della terra- e magari del paese stesso. Che trasformazione.
Sono qui da quattro settimane ormai. Eppure no, non sono ancora andato all’Azadi tower che quella note prima di ripartire ho provato quasi disperatamente ad includere all’ultimo minuto fra le visite di quel viaggio. Quando l’autista mi ha detto che col traffico cittadino il rischio di non arrivare il tempo per il check-in era troppo grande, ho dovuto rassegnarmi al non vedere mai veramente l’iconica torre. Eppure era solo un rimando ad un qualche indeterminato futuro. Un rimando che ora non ho fretta di realizzare, quasi questo passaggio debba essere il passaggio conclusivo di un percorso – un percorso che spero assai più lungo.
Forse lo farò diventare tale, proprio come a Kyiv (un altro viaggio “iniziatico”, a suo modo) ho lasciato tante cose da vedere e fare fino all’ultimo. Ogni iniziazione deve avere la sua giusta conclusione, pare.
Forse per questo, oggi, fa ancora più strano realizzare non solo di essere tornato, ma di essere pure tornato per restare.
Restare in Iran, almeno un po’. Almeno quel tanto che basta per, come mi ha detto una collega il primo giorno di lavoro con un’efficacia di sintesi davvero splendida, “andare oltre i leoni” (in un duplice riferimento al latino hic sunt leones delle mappe medievali e all’antico emblema di Persia).
Se non è un sogno, questo. Eppure avrei dovuto ricordarmi che il confine fra sogni ed incubi non è mai netto e che ad inseguirli non si sa mai dove si va a finire. Ma ora importa ancora?
Vivere l’Iran, almeno un pò.
Vota:
Sette giorni in Tajikistan
O, meglio, sette giorni a Dushanbe. Il meglio che siamo riusciti ad allontanarci dalla capitale è stato una ventina di kilometri. Quindi del “Tajikistan” possiamo dire assai poco. Appena qualcosa in più della sua capitale, Dushanbe.
All’uscita dell’aeroporto a notte fonda la prima impressione del “terzo -stan” (e che simpatico caso scoprire che questo “terzo -stan” ha una moneta da 3 somoni) è un mix fra il caos creato da decine di tassisti che si accalcano per richiamare i passeggeri appena sbarcati e la spontanea gentilezza di uno di loro che mi offre di chiamare il collega che avrebbe dovuto venirmi a prendere ma non si fa vedere.
In generale, con sporadiche eccezioni, devo dire che la gentilezza dei tagiki sarà un tratto ricorrente di questa breve esperienza. Notevole proprio quello stesso collega che la sera della partenza insiste per invitarmi a cena e non farmi aspettare il volo da solo, un tocco tanto gratuito quanto squisito.
La mattina dopo l’arrivo Dushanbe si presenta secondo lo stereotipo delle “nuove” città d’Asia, dell’Asia Centrale soprattutto: palazzoni di vetrate e motivi decorativi piuttosto pacchiani che neppure troppo lentamente stanno soppiantando i vecchi palazzoni di stile sovietico. Quelli erano di quattro o cinque piani, per lo più dei casermoni, questi sono dei monoliti in vetro e acciaio che troneggiano sulla città. Quanti, di questi nuovi spazi, siano effettivamente occupati (e/o necessari per l’uso che la città ne farebbe), resta un’incognita. Le capitali degli -stan si stanno rifacendo il look, così, secondo la moda degli impresari cinesi che qui costruiscono a man bassa. “Cina e Tagikistan amici nei secoli” recita lo striscione rosso a caratteri gialli in ideogrammi e russo sul mastodontico scheletro di quello che diventerà il futuro parlamento.
Chissà quanti debiti sta contraendo questa piccola repubblica incastrata sulla catena del Pamir (uno degli ostacoli più formidabili lungo la via della seta che fu) per soddisfare le megalomanie di grandezza. E chissà quante di queste megalomanie architettoniche sono proprie di Emomali Rahmon, il presidente-padrone in carica dagli anni ’90 (come la maggior parte dei suoi colleghi degli altri -stan, ad eccezione di quelli che sono morti)?
Quello che purtroppo questo slancio di modernizzazione sta rimuovendo sono quei tocchi artistici che gli archittetti sovietici riuscivano ad incastonare nelle loro altrimenti bruttine creazioni – almeno in questa parte dell’ex URSS. Soprattutto mosaici in un mix di realismo socialista e influenze locali, ma anche qualche murales. Tutto questo ora viene rimosso per far spazio ai trenta piani di vetrate. La cosa mi fa parecchia tristezza.
Per il momento qualche tratto ancora si salva, per lo più in periferia ormai, come il bellissimo mosaico dedicato ad Avicenna o quello della giustizia presso la Corte Costituzionale. Bello anche il Borbad, pur nel suo brutalismo addolcito da poche maioliche verdi ben assestate. Ma per quanto ancora?
Eppure al modernismo architettonico si sovrappone un gusto fortemente retro, o forse una patina ideologica passatista. Sempre secondo il gusto di Rahmon? Ci troviamo in Tajikistan ai primi di maggio, proprio a cavallo di quel 9 maggio in cui gli Stati dell’ex Unione Sovietica celebrano la vittoria nella “Grande Guerra Patriottica”, e ovunque si vedono poster e richiami celebrativi proprio del 9 maggio, spesso con motivi sovietici e coi colori nero-arancio del malfamato “nastro di San Giorgio” – oggi simbolo dell’ipernazionalismo russo rivisitato da Putin. I rapporti con la Russia qui vanno ancora alla grande, d’altronde è stato solo al provvidenziale dispiegamento di truppe russe che hanno chiuso la frontiera se nel 2021 al momento della cattura di Kabul da parte dei talebani, centinaia di migliaia di afghani in fuga non hanno potuto “invadere” il Tagikistan in cerca di riparo.
In realtà non si può neppure troppo rimproverare questa severità al Tagikistan e al suo presidente. In fondo è ancora viva nella memoria di molti la realtà della guerra civile che ha insanguinato il paese per buona parte degli anni ’90, contrapponendo il governo a militanti islamici. “Alle quattro del pomeriggio la città [Dushanbe] era vuota“, mi racconta un collega. Fa strano immaginarlo ora, una città piena di vita ad ogni ora del giorno (a momenti sembra Times Square dalla mole di luci) che si svuota interamente al primo pomeriggio.
Proprio poco prima del 9 maggio decidiamo di andare all’opera. Retaggio della dominazione russo-sovietica nella regione: grandi teatri dell’opera diffusi in ogni città, con perlopiù un programma ovviamente russo, ivi incluso balletto. Solo che non riesco a capire il titolo dell’opera o il suo autore, quindi andiamo alla ceca: non potrà essere tanto male. Con nostra grande sorpresa ci troviamo in una rappresentazione recitata – cantata – ballata commemorativa proprio della Grande Guerra Patriottica, con svariate hits del classico repertorio: Katyusha, Malinka, e Le Gru (un pezzo devo veramente commovente che trasmette un aspetto melanconico dell’animo russo spesso nascosto – se la trovate, ve n’è una bella recitazione in italiano di Moni Ovadia). Il tutto accompagnato da foto dell’Olocausto e dal monito “non dimenticare”. Parecchi spettatori, inclusi dei ragazzini, entrano col nastro di San Giorgio appuntato al petto. Devo sforzarmi per nascondere il disagio, pensando a come questo simbolo sia ora impiegato in Ucraina.
Mi è praticamente impossibile giudicare la rappresentazione, aldilà della messa in scena di dubbia qualità (degna di una recita delle medie) e della viva partecipazione del pubblico che canta Malinka con passione. Certo questo squarcio nel quotidiano e nella memorializzazione / mitizzazione (per dirla con Jesi) della Seconda Guerra Mondiale è forse la più vivida spiegazione di cosa passi nella testa di tanti russi pensando al conflitto odierno. Non a caso, il tema ritornerà anche nella difficile chiacchierata con un tassista locale che prova a chiedermi chi, secondo me, sia meglio fra Russia e America. Ogni ragionamento sarà impossibile, destinato a scontrarsi contro un nastro registratore di propaganda.
Eppure, nella stessa identica città, troviamo una signora ucraina di Poltava che da tempo vive e lavora in Tajikistan. Non ho avuto cuore di chiederle cosa pensasse di quel che la circondava.
Fuori Dushanbe riusciamo ad andare solo a Hisar, un paesino presso il quale sorgeva una vecchia cittadella – tappa lungo la via della seta. Della cittadella originale resta ora in realtà solo il portale d’ingresso. Il resto venne distrutto dai sovietici quando occuparono la zona, ci dicono. E viene ora ricostruito ad uso e consumo dei turisti (ma in fondo anche Berlino e Dresda fanno lo stesso, no?).
La visita lascia il tempo che trova, ma il tragitto verso Hisar attraversa una delle fertili valli tagike, dove ci coltiva ogni tipo di frutta: noi ne approfittiamo per gustare fragole, more, ciliegie e albicocche. Sbalorditiva la varietà e la qualità di produzioni agricole, le quali purtroppo hanno uno sbocco commerciale solo verso Kazakhistan e Russia.
Poi, poi c’è il plov. L’Asia Centrale non sarebbe quella che è senza il suo signature dish, il piatto probabilmente più tipico della regione: un riso a base di carote e carne d’agnello (nelle variazioni di spezie, uvetta, berberis, cipolla…).Il primo giorno chiedo lumi ai colleghi su dove se ne possa gustare, e da allora continuerò ad apprezzarlo quasi ogni singolo giorno. Ma ridurre la cucina regionale al solo plov sarebbe ingiusto: come minimo, devo ricordare la varietà di zuppe (anche queste, per lo più base d’agnello), come lo shurbo – che contro il mio scetticismo arriverà quasi ad eguagliare quella leggendaria zuppa gustata in una bettola fuori Bukhara anni orsono-; e i “ravioli” (mi si perdoni l’abuso del nome…) mantis. Il tutto accompagnato da abbondante coriandolo e aneto, che a gusto mio creano un’eccellente combinazione.
E ci sono i rappresentanti di certe agenzie UN, capioni del mondo nel rigirare la frittata e dare fiato ai polmoni senza dire alcunchè che abbia un briciolo di sostanza. Mi domando se facciano dei corsi appositi per questo o se ci nascano proprio. Che dire: chapeau, a modo loro, sono dei maestri.
Vota:
Atomi, consumi e civiltà
Anni fa, all’epoca dell’ultimo (solo in ordine temporale) referendum sul nucleare votai contro la riattivazione di questa fonte di energia nel nostro paese. Non posso dire di essermi “pentito” di quella scelta, ma certo negli ultimi anni l’ho ripensata più volte, già prima dell’invasione russa dell’Ucraina e della conseguente “crisi energetica”.
In realtà, ancora oggi non sono esattamente convinto delle ragioni in favore dell’energia nucleare, trovo tuttavia abbastanza e sempre più persuasive le argomentazioni relative al cambiamento climatico: se l’energia atomica è meno inquinante in termini di emissioni di CO2, questo elemento dovrebbe pesare seriamente nelle nostre riflessioni.
Questo pensiero mi è tornato in mente ieri ascoltando un podcast dell’Economist sulle prospettive della c.d. fusione atomica come fonte di energia, fonte di energia che (come molti) credo possa essere un’entusiasmante svolta. Se arriverà in tempo.
A questi ragionamenti e in queste ipotetiche aperture all’energia atomica si accompagna però un altro, più semplice, pensiero: tutte le fonti “rinnovabili” o “non inquinanti” del mondo non serviranno a nulla se non rivediamo, ripensiamo e riduciamo i nostri consumi energetici.
In particolare l’energia atomica, con la sua potenzialmente immensa produzione di energia, non risolverà un bel nulla se prima e a monte di queste centrali non riflettiamo sui consumi.
Parlando del bilancio dello Stato, mio padre usa spesso l’immagine di un bilancio familiare: se una famiglia guadagna 10 e spende 20, dice, prima o poi dovrà guadagnare 15 e spendere 10 per rimettere le cose in ordine.
Immaginiamo ora che quella famiglia “vinca alla lotteria”: avrà forse bisogno di rimettere le cose in ordine, di spendere meno?
Ecco, il mio timore con ogni nuova fonte di energia che viene scoperta (più o meno “verde” che sia) è che questa sia come una vincita alla lotteria: una “scusa” per non affrontare il problema di fondo e continuare a rinviare scelte difficili, cambiamenti di paradigma di cui invece avremmo urgentemente bisogno.
Insomma, se anche domani avessimo accesso all’energia nucleare (fusione o fissione che sia), ma non pensassimo minimante di ridurre i nostri consumi ed i nostri stili di vita, continueremo semplicemente su questa rotta sempre più energivora, consumando più e più energia e continuando la rincorsa allo sfruttamento estremo delle risorse esistenti e la scoperta di nuove.
Pensate a quanti apparecchi di vario genere attaccate alla presa ogni giorno (o più volte al giorno) per caricarli e continuare ad usarli ad oltranza: uno o due pc; uno o due (o tre) smartphones; magari un lettore di libri digitali; un paio di casse ed uno di cuffiette bluetooth; magari la vostra macchina elettrica; il rasoio; il tagliaerba; il robot aspirapolvere; le powerbank per tutti gli aggeggi di cui sopra…. i milioni di gadgets piuttosto inutili che ci vengono propinati ogni giorno (un esempio idiota: la borraccia che sterilizza l’acqua con un raggio UV). Tutte cose bellissime, fighissime, utilissime… di cui non abbiamo assolutamente bisogno. Tutte cose che magari prese singolarmente consumeranno poco, pochissimo, quasi nulla, ma che continuano a sommarsi e che complessivamente pesano sempre di più sul vostro bilancio energetico, sulla vostra impronta ecologica senza che ce ne rendiamo minimamente conto.
Pensate a quante di queste cose avevate anche solo 2, 5 anni fa. Non so voi, ma sebbene cerchi di limitare questi acquisti energivori, anche io ho aumentato il numero di apparecchi che necessitano di energia elettrica anche solo nell’ultimo paio d’anni.
Con un ragionamento forse stupido, prima di sviluppare nuove fonti di energia, vorrei cominciassimo a rivedere questa corsa ai consumi che non ci porterà da nessuna parte. Magari sarà irrealizzabile, ma non si potrebbe (ad esempio) pensare ad un “energy cap“, un tot di energia elettrica cui ciascun cittadino ha potenzialmente diritto (che lo consumi o no) e che non possa eccedere? Un limite aldilà dei consumi effettivi, un limite che ci costringa a ragionare nuovamente non in termini di assoluti, a re-interiorizzare il concetto stesso di limite. Indipendentemente dalla fonte con cui quella energia è prodotta (o almeno relativamente indipendente… con dei quozienti?).
Se proprio vogliamo, si potremmo aprire questo sistema ad un minimo di commerciabilità (come per le carbon quotes).
Se restiamo nella logica di consumi illimitati, non ci saranno mai risorse sufficienti o strumenti che ci consentano di evitare la catastrofe ecologica verso cui stiamo correndo.
Forse l’energia elettrica potrebbe essere un buon punto per partire, un punto meno visibile (quindi forse meno “traumatico” che il pensiero di non poter comprare un telefonino nuovo ogni anno), ma altrettanto impattante.
Vota:
Lasagne
“Sono come strati di lasagne” diceva un mio vecchio prof parlando del pluralismo giuridico (compresenza di diversi sistemi normativi) nei paesi asiatici. Strati distinti, ma non interamente separati: comunicanti.
Ancora oggi, difficilmente trovo un’immagine migliore per descrivere lo stato di molte questioni globali. Primo fra tutti, il dibattito attorno al conflitto in Ucraina.
Trovo in realtà abbastanza stucchevoli la frequenza e il modo con cui praticamente tutti i “giornalisti” e commentatori insistano nel chiedere alla neoeletta segretaria del PD Schlein (a proposito: !) di risolvere dinnanzi a loro la presunta aporia fra il suo proclamato pacifismo e la fornitura di armi / sostegno all’Ucraina. Come se Schlein, o chiunque altro, avesse una bacchetta magica.
Purtroppo, e chissà come mai la cosa accade soprattutto verso i rappresentanti della sinistra, ci si ostina a non rendersi conto che la realtà è contraddittoria, non comodamente plasmata per adattarsi ai nostri principi. Di conseguenza, sono questi ultimi a doversi adattare alla prima, anche a rischio di apparire contraddittori.
In realtà sarei propenso a dire che tali contraddizioni di principio non sussistono affatto. Sono strati diversi delle “lasagne”, che non possono essere presi separatamente e che occorre cercare di “afferrare” tutti assieme, pur sapendo che -proprio come nelle lasagne- qualcosa inevitabilmente cadrà fuori e dovrà poi essere ricomposta.
L’aporia fra pace e giustizia (sintetizziamo con questo denso concetto tutte le posizioni di “difesa della sovranità Ucraina”, “rispetto del diritto internazionale” e via cantando) è fra le più vecchie del mondo (già Aristotele si chiedeva se fossero nati prima i dibattiti pace vs giustizia o le meretrici, che notoriamente erano anche le migliori nei suddetti dibattiti) e resta ancora irrisolta. Ogni santo giorno, per ogni dannato conflitto che si svolge sulla faccia della terra, la diatriba si ripropone sempre nuova e sempre irrisolta: la soluzione del Sud Africa non va bene per il Mozambico, quella dell’Uganda non va bene per il Ruanda (e nessuna di esse va bene per il Congo) e quella dello Sri Lanka non va bene per la Colombia. Dove tracciare la linea fra pace e giustizia è un giochetto che deve essere calato nel contesto, nelle culture, negli eventi e nelle priorità locali. E’ un compromesso che deve rispondere ad esigenze sempre differenti, universalizzatili solo in astratto.
Irrisolta perché, proviamo ad ammetterlo almeno fra noi, una “soluzione” universale ed adattabile e tutte le circostanze non esiste.
Così, mi permetto di dire, non ha senso chiedere se si debba o no sostenere l’Ucraina coi mezzi necessari al contesto attuale o privilegiare una soluzione pacifica e pacificatrice. Le due cose non possono che andare assieme.
Per dirla altrimenti: non ho mai avuto particolare simpatia per Veltroni e trovato la sua retorica del “ma anche” piuttosto insulsa, tuttavia in questo caso torna appropriata. Difendere l’Ucraina, ma anche costruire la pace.
Anni fa, arrivato da poco a Londra, mi trovai in una marcia in memoria della “Battaglia di Cable Street” nella quale i fascisti britannici di Oswald Mosley furono fermanti da socialisti, comunisti e anarchici. Durate la marcia iniziammo un lungo e interessantissimo dibattito con un paio di amici sul concetto di non-violenza e sulle trasformazioni sociali (dibattito che sarebbe poi proseguito sulle pagine del superbo Frantz Fanon) e uno di loro mi citò un libro che già nel suo titolo riassumeva l’intera questione “This non-violence shit will get you killed” (trad. libera “Questa c**ta della non-violenza ti farà uccidere”).
Per quanto personalmente non mi reputi pacifista, sono molto vicino alle posizioni pacifiste, se non altro perché a differenza di quasi tutte le persone invitate a dibatterne, so esattamente cosa voglia dire un prolungamento del conflitto, e vivo (nel grado che mi è possibile) la sofferenza di questo prolungamento. Nonostante ciò, mi sono sempre predicato realista in ambito internazionale. Fine della guerra appena possibile, quindi, ma continuazione della guerra fintantoché necessario.
Posizione terribile, lo so. Non che mi piaccia molto, eh.
Terribile, ma almeno non contraddittoria come ci si vorrebbe far credere. Non v’è, a mio giudizio, contraddizione fra i due termini dell’equazione per una ragione molto semplice: la pace si costruisce, ma si costruisce restando vivi. E, come dicevamo, questa ca**ta della nonviolenza o del pacifismo a tutti i costi ci farà uccidere tutti. Sarebbe come esigere delle politiche ambientaliste senza far pressione sui governi…
Badate, non voglio riciclare qui i miseri slogan di chi ci dice che dobbiamo continuare a sostenere l’Ucraina senza sapere che voglia dire. Voglio piuttosto dire che se abbiamo a cuore i destini degli Ucraini (prima che del paese Ucraina) dobbiamo costruire entrambe le posizioni, ben consci che ci troveremo schiacciati nel mezzo da parte di tutti i commentatori specializzati nell’ipersemplicazione. Quelli che, prendendo spunto dalla retorica di Taleb, mangiano le lasagne una fetta alla volta.
Dobbiamo supportare la difesa dell’Ucraina e degli Ucraini coi mezzi necessari, siano anche (anche, ma non solo) in questa fase quelli militari: perché, come purtroppo sostengono anche humanitarians ucraini (ad esempio a Trumanitarian e The New Humanitarian – Weapons as aid?) , in questo momento supportare le forze armate ucraine è fra i migliori modi per salvare vite –sic-. E al contempo dobbiamo costruire la pace, continuare quel difficile lavoro di tessitura che ad un certo punto darà i suoi frutti. Chiunque conosca un minimo di storia (dire “scienza” parrebbe troppo) delle negoziazioni internazionali, ivi comprese quelle di pace, sa che queste si costruiscono per canali spesso sotterranei, tortuosi, quasi sempre imprevisti, ma solo con un incessante lavoro di tessitura, creazione e sviluppo di legami e creatività nel formulare, aggiornare ed adattare proposte e soluzioni pratiche.
Ma questo lavoro di costruzione non può limitarsi a retoriche prese di posizione, richiede semmai lo stesso impegno, spesso sotterraneo (anzi: quasi sempre sotterraneo) per scavare canali, limare le posizioni e avvicinare l’innavicinabile.
Dove tracciare queste linee è un giochetto che deve essere calato nel contesto, nelle culture, negli eventi e nelle priorità locali. E’ un compromesso che deve rispondere ad esigenze sempre differenti, universalizzatili solo in astratto. E’ un esercizio che richiede di ascoltare in primo luogo gli ucraini e i russi con loro, costruendo un equilibrio che sia accettabile da tutti. Ma questo equilibrio non può essere costruito se solo una delle parti può spingere l’altra nel baratro.
Per favore, smettiamola dunque di chiedere se occorra essere pacifisti a parole o “sostenere l’Ucraina costi quel che costi”. Servono entrambe le cose. Serve spendersi la pace, concretamente, e serve sostenere l’Ucraina – sia questo con armamenti, con aiuti economici e con tutti gli aiuti umanitari disponibili (non so se 5 generatori valgono un carro armato, in questa lotta sisifea, ma so senza dubbio che quei 5 generatori possono cambiare l’inverno di parecchie persone, che resta un passo importante per permettere loro di arrivare in fondo a questa sporca storia). Non è questione di “porre condizioni” o termini di scadenza ai nostri aiuti all’Ucraina, quanto di tenere aperti canali di comunicazione ed usarli.
* ps: bel titolo, versatile. Potrebbe essere l’inizio dell’ennesima serie.
Vota:
e lo chiamano lutto nazionale
Poco meno di dieci anni fa pubblicai questo post che segue riguardo un’altra “tragedia del mare” (originariamente su i Discutibili). Non trovo altro da aggiungere, oggi, se non riproporlo integralmente.
E chiederci quanto male, quanta malvagità, intercorra in questi dieci anni.
Chiedercelo, e provare tanta, tanta vergogna.di redpozNon sapevo, non avevo capito. Non so, non ho capito.
Cosa c’è da capire? Cosa? Quanti?155 tratti in salvo, 111 corpi. Il resto? Non si sa.
Ecco la contabilità. Di che? Del canale, di “negri”, della legge Bossi-Fini, d’Africa, di migranti, di uomini. Sepolti galleggianti. Sepolti in mare, dal mare; come si faceva una volta con i marinai morti in alto mare. Ma niente salve di cannone, niente squilli tristi di tromba, niente pellegrinaggi ai cimiteri d’eroi.
Ma tanta, tanta, retorica. La retorica di quelli che “mancano i fondi“, “servono politiche comunitarie“, “via la legge Bossi-Fini“, “il Nobel per la pace a Lampedusa” (ma se il Nobel per la pace lo merita qualcuno, semmai sono i superstiti e loro). E tu li ascolti e pensi pure che, sì, hanno pure ragione.
Diavolo d’un mondo!, hanno ragione: hanno ragione a dire che gli uomini non possono continuare a morire così, come animali.Stamattina ho aperto il giornale, non ho letto nulla. Ho guardato solo le foto: i sacchi di plastica; le etichette senza nomi; le macchie nero-bianche in mare. Cosa avrebbero potuto aggiungere le parole?
Anzi, due cose le ho lette, fra i titoli: ho letto del gasolio ed ho letto di quel pescatore che si è tuffato in acqua per salvare non so quante persone, prima di scoppiare a piangere.
Credo questa storia sia il messagio più forte che ci arriva oggi: piangere.
E’ facile per me, lontano, guardare le foto e sentire la retorica riempire l’immenso vuoto che si è creato. E’ facile restare lucidi, razionali e pensare alle politiche comunitarie; alle tragedie che quelle persone cercano di lasciarsi alle spalle (Eritrei, leggo, l’ennesimo “buon” regime che il nostro Stato continua a supportare). Il difficile, qui a più di mille kilometri dalla tragedia, è mettersi a piangere. Eppure, sarebbe l’unica cosa giusta da fare.Lutto nazionale, hanno proclamato.
Immagino sia esistito un tempo in cui, anche qui, queste parole avevano un senso. Forse nell’era di un cattolicesimo ancora vissuto, per quanto dogmatico; forse nell’immediato entusiasmo della fondazione di questa “nazione”: forse allora si aveva il sentimento di dolore diffuso che dovrebbe marcare il “lutto nazionale”. Forse allora avremmo sentito pesare sulle spalle di tutti e ciascuno la tragedia, la sofferenza che colpiva l’intera comunità.
Oggi no. Oggi non più. Oggi, nel cristianesimo post-edonista di una società consumista, rattrappita nell’individualismo senza alcuna prospettiva al di fuori di sé; oggi in uno Stato che ha perso qualsiasi senso di cittadinanza e cittadino; oggi un sentimento tanto rarefatto neppure più ci sfiora.
Paroloni, lo so. Eppure dovremmo guardare per un attimo oltre quei paroloni; scostarli per guardare cosa siamo diventati.E’ tanto facile essere “esseri morali“, provare Mitleid, compassione ed empatia quando il dolore ci è vicino: lo facciamo ogni giorno, anche col nostro cane (avvicinarsi alle vittime, non a caso, è una delle prime lezioni per non restare indifferenti). Ma quanto è difficile quando è così distante, diffuso condiviso: ecco, l’effetto “spettatore”, bystander, più siamo, più confidiamo che ci pensi qualcun altro. Altro che “nessun uomo è un’isola“!
E questo dolore che vorrebbe esser diffuso e calarsi in ognuno di noi, diventare massa e lezione morale, resta sospeso in una nuvola.
Un dolore disperso, che non assume consistenza: in una società di individui anche il dolore, il lutto, ha solo dimensione singolare.Cosa siamo diventati.
Una società di retorica, come la mia ora; una società che accetta l’esistenza di una legge come la Bossi-Fini; che accoglie i “vaffa” come azione politica; che si indigna per gli scudetti rubati e cos’altro?Ricordate gli “angeli del fango“? A loro mi viene da pensare in questo momento, a loro che corserò perché sentivano che quella in atto era una tragedia comune, un dolore che li colpiva tutti. Sentivano veramente, nella viva carne, che per ogni pagina di Dante persa se ne andava qualcosa di loro.
E noi? Noi sentiamo che, come predicava John Donne, con ognuno di quei corpi galleggianti se ne va a fondo una parte di noi? Noi invischiati in una sequela di tragedie quotidiane, estemporanee ma onnipresenti, saremo in grado di correre a Lampedusa?
No, io non lo sarei. Infatti sto qui, seduto alla scrivania. Ed ecco che “quelli” lì li chiamiamo eroi. Loro sì: prendono e vanno. E più le nostre misere figure si ripiegano nella retorica, nella quotidianità insensibile al lutto condiviso; più loro si innalzano sulle nostre teste ricurve, si stagliano come giganti. Ma quanto grandi sarebbero in realtà se noi tutti rialzassimo il capo?
Ogni volta che sento queste storie, mi rimbomba in testa quella frase di Brecht: “Beato il popolo che non ha bisogno di eroi“. Ogni volta che la sento pronunciare, mi sembra sempre che sia detta senza capirla, come un’invocazione ad una vita tranquilla, senza scossoni, che renda superfluo l’eroismo. Io, quando la penso, penso invece immancabilmente che sia un appello a tutti, una chiamata ad esser tutti all’altezza della vita, che allora nessuno sarebbe “eroe”.Qualcuno era […] perché credeva di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri.
Qualcuno era […] perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo.
Perché sentiva la necessità di una morale diversa.
Perché forse era solo una forza, un volo, un sogno era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita.
Sì, qualcuno era […] perché, con accanto questo slancio, ognuno era come… più di sé stesso.
Così cantava Gaber, in una delle sue ultime canzoni. E non importa “cosa” si era. Per questo l’ho cancellato. Perché l’importante era essere.
Non sapevo, non avevo capito. Non so, non ho capito.
Cosa c’è da capire? Cosa? Quanti?
155 tratti in salvo, 111 corpi. Il resto? Non si sa.
Ecco la contabilità. Di che? Del canale, di “negri”, della legge Bossi-Fini, d’Africa, di migranti, di uomini. Sepolti galleggianti. Sepolti in mare, dal mare; come si faceva una volta con i marinai morti in alto mare. Ma niente salve di cannone, niente squilli tristi di tromba, niente pellegrinaggi ai cimiteri d’eroi.
Ma tanta, tanta, retorica. La retorica di quelli che “mancano i fondi“, “servono politiche comunitarie“, “via la legge Bossi-Fini“, “il Nobel per la pace a Lampedusa” (ma se il Nobel per la pace lo merita qualcuno, semmai sono i superstiti e loro). E tu li ascolti e pensi pure che, sì, hanno pure ragione.
Diavolo d’un mondo!, hanno ragione: hanno ragione a dire…
View original post 803 altre parole
Vota:
Il tradimento dei chierici
C’è quasi una nota di stupore nei commentatori occidentali quando constatano la mancanza di sostegno delle politiche anti-russe e a sostegno dell’Ucraina da parte dei paesi del cosiddetto “Sud del Mondo” [global south]. Dinnanzi ai voti contrari o alle astensioni alle risoluzioni della Nazioni Unite che a vario titolo condannano la Russia per l’aggressione all’Ucraina, pare che i commentatori si stupiscano del fatto che questi paesi non supportino le posizioni dell’ “Occidente”. Essi paiono rivolgere a questi paesi domande quali “Ma come, preferite la dittatura alla democrazia? Preferite un sistema mondiale potenzialmente dominato dagli autoritari e repressivi cinesi piuttosto che dai liberali americani?” – domande che non di rado celano un malessere ed un giudizio, come se quei paesi che non si schierano con l'”Occidente” siano stupidi/traditori/ingrati/incompetenti…
[d’ora in avanti smetterò di utilizzare il concetto di “Occidente” virgolettato, dando comunque per scontato che si tratti di un’etichetta che andrebbe problematizzata]
Contro questo (falso?) stupore, contro queste domande retoriche e queste condanne di tutti quei paesi che non sostengono la “causa”, vorrei sollevare se non una vera e propria obiezione, per lo meno una domanda.
Che piaccia o meno, a diplomazia è al crocevia fra il suk e le pulsioni ideali. Credo dunque di poter dire senza timore di smentita che molte decisioni diplomatiche sono frutto del più classico do ut des, dello scambio e del commercio (d’influenze). D’altronde l’abbiamo insegnato e praticato noi occidentali per primi: un (dollaro) vale uno (dollaro) – a prescindere dalla provenienza; e non possiamo stupirci se ora il mondo applichi i nostri dettati.
Dall’altro lato della medaglia, quello ideale, si materializza invece lo stupore. Da decenni gli Stati Uniti e l’Occidente dietro di loro si fanno campioni della “libertà”, della “democrazia” contro la dittatura e le varie oppressioni incarnate dai sistemi politici “orientali” rappresentati dall’URSS-Russia, teocrazia iraniana o dalla Cina. Per un certo tempo è stato anche vero (pensiamo alla Crisi di Suez del 1956); per lungo tempo è stato una foglia di fico che nascondeva la lotta per il dominio globale durante la Guerra Fredda, nella quale “a casi estremi, estremi rimedi” e ci si concedeva alcuni sgarri (tutta l’America Latina delle dittature, ad esempio… dall’Argentina a Cile, dalla Bolivia al Brasile e via dicendo). Ma forse questi sgarri potevano passare perché nello stesso “campo” occidentale c’era comunque chi faceva il controcanto (gli Stati europei che condannavano senza riserve queste stesse dittature).
Con la fine della Guerra Fredda questa retorica non è venuta meno (pensiamo, appunto, all’export di democrazia in Iraq o Afghanistan), ma si è trasformata dall’interno.
Le “democrazia” & “libertà” di cui l’Occidente si faceva promotore negli anni della Guerra Fredda era -quando non apertamente contraddetta dal supporto a dittature militari- almeno implicitamente una social-democrazia: una democrazia che conteneva impliciti in sé alcuni precetti di giustizia sociale, sebbene fermamente ancorati ad un modello capitalistico. Sappiamo invece che dagli anni ’80 circa, questo modello è stato progressivamente svuotato e rivoltato in qualcos’altro: nel sistema neo-liberale dove l’unica concessione alla giustizia sociale è la profezia del “trickle-down“, o (detto altrimenti) l’idea che finché la torta continuava ad allargarsi tutti ne avrebbero beneficiato – senza bisogno di “battaglie sociali” per un’equa distribuzione.
Fino agli anni ’80 circa, anche in Occidente viveva l’idea secondo la quale una piena e compiuta “democrazia” implicasse un minimum di diritti socio-economici, ovvero l’idea che per avere un effettivo sistema di distribuzione del potere politico in modo egalitario, occorresse andare ad incidere anche sui fattori a monte delle elezioni, sulle disuguaglianze economiche e di potere. Questa era la logica anche del cosiddetto “Rapporto Beveridge” pubblicato in Gran Bretagna durante la Seconda Guerra Mondiale – una concezione “massimalista” della “democrazia” adottata per esempio anche dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2000 per la quale “Democracy is based on the freely expressed will of the people to determine their own political, economic, social and cultural systems and on their full participation in all aspects of their lives“. Ovviamente, “determinare” il sistema socio-economico e “partecipare pienamente” in tutti gli aspetti della vita non è esattamente possibile in condizioni di indigenza o di estrema disparità economica.
Con l’avvento del neoliberalismo e della sua logica da “il mercato regola tutto”, ogni interesse o velleità di giustizia sociale è venuto meno. E, con esso, il concetto di “democrazia” è stato relegato al suo significato minimo: partecipazione ad un processo elettorale, formalmente corretto – ma senza alcuna considerazione dei suoi aspetti “sostanziali” (la c.d. definizione “minimalista” o Schumpeteriana.
Un sistema nel quale non fa alcuna sostanziale differenza il fatto che un tycoon col controllo di svariate reti televisive o un multimiliardario in grado di comprare media e visibilità concorrano tranquillamente per cariche politico-istituzionali.
Esplicitamente o meno (molto spesso in realtà in modo del tutto implicito, semplicemente continuando ad alimentare i grandi giri d’affari e i conglomerati industriali transnazionali), quest’ultimo è stato il modello socio-economico-politico che l’Occidente ha esportato da allora. E questo è il modello di “democrazia” & “libertà” che da quarant’anni a questa parte il “Sud del Mondo” osserva, recepisce e attualizza nei propri paesi. Un modello nel quale tanto la “democrazia” quanto la “libertà” restano più astratte ed ipotetiche che reali e vissute. Un modello nel quali i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Anzi, in modo ancor più accentuato proprio in quei paesi del “Sud del Mondo”.
La mia domanda allora è: come può una popolazione di un qualsiasi Stato di questo “Sud del Mondo” non disilludersi dinnanzi alla retorica di “democrazia” & “libertà” che continua a condannarli all’indigenza? Come possiamo stupirci che il “Sud del Mondo” che da decenni ormai pratica varie forme di democrazia elettorale senza vedere alcun sostanziale cambiamento nelle proprie condizioni di vita (chiedere ai nigeriani che hanno appena votato, chiedere ai mozambicani o ai sudafricani… chiedere ai congolesi!) non si senta attratto da qualche alternativa, fosse pure non soddisfacente i dettami della democrazia elettorale?
Personalmente, mi pare piuttosto difficile. Anzi, mi pare addirittura normale che di fronte ad un retorica che si è sperimentato esser vuota, una retorica alternativa di “anti-imperialismo” (per quanto non veritiera) presentata dalla Russia e dalla Cina abbia un certo appeal. Perché dinnanzi ad un modello che ha dimostrato di non funzionare, di non dare i risultati tanto promessi, qualcuno non dovrebbe pensare di cambiare? Cosa impedisce ai paesi del “Sud del Mondo” di pensare che un ordine mondiale a trazione sino-russa (o meramente cinese) dovrebbe dare risultati peggiori di quello basato sull’attuale dominio neoliberale-nordamericano?
Insomma, al di là del do ut des (nel quale l’Occidente si trova in difficoltà di fronte alle risorse cinesi), cosa dovrebbe convincere il “Sud del Mondo” che il modello di ordine globale proposto fin qui dall’Occidente sia migliore di quello prospettato dalla Cina e dalla Russia? Le promesse di “democrazia” & “libertà” non si sono realizzate; quelle di sviluppo economico men che meno; e la logica di “rispetto” dell’ordine giuridico globale (inviolabilità delle frontiere) può trovare altri canali.
In questo riproporre una retorica di “democrazia” & “libertà” piuttosto vuota, vi vedo quel tradimento di quei chierici e predicatori. Non credo si possano predicare falsi dei tanto a lungo senza poi venire smascherati nella propria ipocrisia. E temo qualcuno a Sud stia cominciando a rendersene conto.
Vota:
In difesa della Germania
Certo: so benissimo che la Germania non ha alcun bisogno del mio misero contributo a sua difesa. Eppure, nel mio gusto per le voci “dissonanti”, vorrei qui spendere alcune parole appunto in difesa del paese tedesco, o meglio: della sua politica estera nei confronti con la Russia, per come portata avanti dai successivi governi Schroeder e Merkel.
Piccola premessa prima di entrare nel merito: per quanto pare quasi oggi ci si diverta a “sparare” (metaforicamente) su Angela Merkel e sulla sua improvvida gestione degli affari esteri, credo di potermi classificare fra i pochi che neanche all’epoca del suo massimo splendore politico rientravano fra i “fan” della Merkel – se non altro per un’istintiva reazione di sospetto che mi scatta quando si tessono troppo le lodi di qualcuno. Ma veniamo al dunque.
Il refrain oggi comune contro la Germania e la sua politica estera verso la Russia – quindi contro Schroeder e Merkel – è l’accusa di aver aperto troppo alla dipendenza commerciale verso quel paese (per il gas e la gestione di snodi strategici connessi), nella speranza che questo conducesse ad una maggiore integrazione fra Europa e Russia e quindi prevenisse il rischio di conflitti.
“Poveri illusi!“, pare tutti dicano ai politici tedeschi che condussero queste scelte strategiche, “come se non aveste potuto vedere che vi consegnavate nelle mani dell’Orso / nemico…“. Lo stesso identico errore che le potenze europee commisero negli anni antecedenti la Prima Guerra Mondiale, si osserva: l’illusione che l’integrazione economica possa fungere da vaccino contro i conflitti geopolitici.
Ora, il mio personalissimo gusto per l’archeologia politica mi porta ad una semplicissima osservazione: (“e tuttavia, d’altra parte, ciò che bisogna dire, e che tutti sanno del resto…”) questo approccio è in realtà stato proposto e riproposto fino allo sfinimento proprio da quel paese egemone (gli Stati Uniti) che ora criticano la Germania. Il neoliberismo e la globalizzazione capeggiati dagli USA negli ultimi trent’anni sono stati, anche se non soprattutto, questo processo di integrazione economica. Vedasi la famosa teoria di Friedman secondo la quale “due Stati nei quali sono presenti McDonald’s non sono mai andati in guerra l’uno contro l’altro” (falsa già sin dagli anni ’90 peraltro). Rinvio di nuovo all’eccellente libro di Stuart Elden per una migliore sintesi di questo argomento. Insomma, per dirla in termini schietti, siamo al bue che da del cornuto all’asino.
La sostanziale differenza fra il bue (i molti buoi in realtà) e l’asino in questa circostanza, forse l’unica, è la posizione cultural-geopolitica che distingue i suddetti buoi e l’asino tedesco. I vari buoi, Stati Uniti e Regno Unito in primis (ma seguiti in comoda compagnia da altri Stati come Polonia e Svezia) sono potenze sullo scacchiere globale -o almeno continuano a considerarsi tali-, dunque in diretta competizione proprio con la Russia (per Svezia e Polonia la competizione è più locale e immediata che globale). Dunque, in fondo, quel che rinfacciano alla Germania non è tanto l’integrazione economica in sé, quanto l’integrazione economica con un loro potenziale avversario.
Ma quel che si omette di considerare è che alla Germania, dopo la Seconda Guerra Mondiale, manca completamente questa prospettiva di competizione geopolitica. Da quasi ottant’anni la Germania è stata resa “monca” di ogni velleità di potenza che vada aldilà della mera sfera economica (e lo si vede bene nell’imbarazzo con cui questo paese affronta il problema del conflitto e la riluttanza che lo accompagna – sin dagli anni ’90). Insomma, per continuare ad usare metafore spicciole, è come se dopo aver accecato qualcuno lo si accusasse di non vedere quel che gli accade davanti e di andare a sbattere.
Non tenterò neppure di emettere qui un giudizio sulla bontà o meno di quelle politiche estere ed economiche tedesche e dei rapporti che la Germania ha costruito con la Russia. Mi accontento solamente di far notare che quelle politiche furono, almeno in parte, la conseguenza di un sistema politico-economico globale creato e sostenuto proprio dagli Stati Uniti. D’altronde, come osservato in un ottimo articolo del Guardian (tradotto in podcast), quando la competizione geopolitica fra Stati Uniti e Russia/Unione Sovietica era ancora attuale e la Germania cominciava a considerare la possibilità di forniture di gas da quest’ultima, le pressioni e le argomentazioni geopolitiche furono assai consistenti per minimizzare quest’ipotesi. Difficile sorprendersi se quasi cinquant’anni dopo, con una Russia che per lungo tempo non pareva rappresentare alcun serio contendente globale, la situazione si sia quasi ribaltata.
Vota:
I conti si pagano
E’ in questi giorni in corso un’interessante, diciamo così, discussione a Bruxelles fra i capi di governo durante la quale la “nostra” è attesa da tutti presentare richieste di “flessibilità” nell’esecuzione del PNRR italiano per assicurare che non perderemo soldi, o almeno non troppi. In parallelo, procedono discussioni sulla possibilità per l’Unione Europea di fare altro debito comune (come per il PNRR) per finanziare aiuti alle imprese: misura, questa, sostenuta principalmente proprio dal nostro paese, che avendo visto gli aiuti di Stato messi a disposizione da paesi come Germania e Francia (sempre in virtù di regole europee) ha paura di trovarsi preso indietro.
C’è pure una discreta possibilità che almeno la prima di queste richieste abbia successo, in uno scambio do ut des proprio con paesi quali Germania e Francia, i quali potrebbero essere tutto sommato contenti di lasciarci spendere soldi che ci sono già stati destinati a condizione di poter continuare a “pompare” le loro imprese. A me suona un pò come un errore, ma lo scopriremo solo nel futuro.
Poiché è facile scoprirsi smemorati, credo sia utile fare un passo indietro e riflettere sulle origini meno immediate di questa situazione (quelle immediate le conosciamo: prima la pandemia, poi il conflitto in Ucraina). Chiediamoci dunque perché l’Italia porta tali richieste al tavolo della discussione europea?
Molto semplicemente:
– Per un debito comune vs aiuti di Stato, perché l’Italia non può permettersi di concedere aiuti di Stato contraendo debito in proprio;
– Per la “flessibilità” nell’esecuzione del PNRR, perché come riportano vari media ormai da qualche tempo, le amministrazioni locali che dovrebbero gestire i bandi per i progetti non hanno i tecnici per svolgere questo lavoro: mancano i ragionieri / contabili, mancano i geometri ed architetti… mancano tutte quelle figure tecniche che dovrebbero formulare e valutare proposte di investimento e sviluppo per la comunità.
Fin qui tutto bene, spero. Ma occorre fare almeno un ulteriore passo indietro. Di nuovo, chiediamoci perché siamo in questa condizione?
– Per il debito, si sa: l’Italia ha negli anni passati contratto troppo debito, che ovviamente ci espone alle “bizze” dei mercati finanziari (quelli che i soldi ce li hanno prestati e continuano a prestarceli): il famoso spread. La storia sull’ordine del debito è piuttosto vecchiotta e risaputa (anche se magari non in termini precisissimi). Quello che per lo più si tende ad ignorare o sorvolare è quanto è avvenuto fra l’origine di quel debito e i giorni d’oggi: le mille e mille promesse di ripagarlo. C’è stato solo un preciso momento nel quale, a mia memoria, questa promessa era oggetto di precise politiche per metterla in atto: gli anni dell’ “avanzo primario” di un certo governo di un certo professore (Prodi). Mi pare fosse attorno al 2011. Ma evitare di distribuire mance elettorali costava caro, per quanto avrebbe avuto una grandissima utilità dieci anni dopo… continuare la strategia di ripiegamento del debito avrebbe ora consentito al nostro paese di avere quelle finanze (il “fieno in cascina”), o perlomeno una certa flessibilità e minore dipendenza dai mercati finanziari per fare debito oggi, quando più sarebbe necessario.
– Riguardo la carenza di tecnici nelle pubbliche amministrazioni, tendiamo a dimenticare (e i media contribuiscono a questa smemoratezza collettiva riportando solo l’ultimo dato della serie) che questa è la precisa conseguenza di precise scelte politiche. Qualcuno ricorda i famigerati “blocchi delle assunzioni nella P.A.”? Ecco. Per anni ed anni, ripetendo mantra (sbagliati) della Banca Mondiale si è pensato che il costo della pubblica amministrazione fosse troppo alto, e che il modo più semplice per tagliarlo fosse tagliare i costi diretti – il personale. Ci si è completamente scordati che così facendo si bloccava l’operatività di quelle stesse amministrazioni pubbliche, ora impossibilitate a svolgere il loro ruolo con efficienza (ed efficacia).
Così vediamo oggi amministrazioni locali che non possono approvare ristrutturazioni di scuole (a Napoli, vedasi ultima portata di Report) e amministrazioni locali che pur non avendo un particolare bisogno di investimenti nello stesso settore possono portarli avanti, perché ci sono i soldi e hanno le capacità di programmarne la spesa (il mio comune, ad esempio, che coi soldi del PNRR progetta un nuovo asilo… probabilmente destinato a restare semivuoto).
Se, volendo provare a fare qualche ipotesi controfattuale, avessimo continuato a ridurre il debito (tramite il meccanismo dell’avanzo primario, o altro) nel 2020 ed oggi ci saremmo potuti permettere di ottenere nuovi prestiti per investire, finanziare e sostenere le imprese in questo momento di crisi sistemica.
Se negli anni scorsi avessimo analizzato meglio i costi della P. A. e individuato modelli di risparmio più ragionati rispetto ai semplici tagli lineari / blocchi delle assunzioni, oggi probabilmente avremmo quei tecnici in grado di gestire i progetti e spendere i soldi del PNRR in tempo, senza domandare nuove eccezioni alle regole.
Un’ultima chiosa su questo punto: spettasse a me decidere, personalmente un parte di quei soldi del PNRR li avrei destinati proprio a ricostruire le competenze e le capacità tecniche delle P. A. – così almeno da evitare di continuare a buttare (non spendere) milioni e milioni di finanziamenti europei che ci arrivano ogni anno, e non siamo spesso in grado di utilizzare (anche questa, storia vecchia).
Il tempo arriva sempre a farci fare i conti con le decisioni che si sono prese. E i conti, inevitabilmente, si pagano.
Vota:
Cerca post
TagCloud
Albert Camus amore Argentina Australia Beppe Grillo blog campagna elettorale cinema città Congo corte costituzionale democrazia DRC Egitto elezioni Elly Schlein esame avvocato esame di stato Euro facebook fascismo film forze armate Francia Galles humanitarians ICTR i discutibili Iran Irlanda Irresistibilmente Iran istituzioni Italia Kyiv Laura Puppato lega nord libertà linguaggio Londra M5S Mario Monti Matteo Renzi media memoria Mondiali di rugby Morsi morte Movimento 5 Stelle Namibia Nigeria nowhere Namibia Nuova Zelanda Partito Democratico paura PD Pierluigi Bersani Pippo Civati politica Presidente della Repubblica primarie rugby Rugby World Cup Russia Silvio Berlusconi sinistra Siria Standing in the -stans storia Sud Africa tasse Tribunale penale internazionale per il Ruanda Ucraina Unione Europea Uzbekistan violenzaBlogroll
- BBC
- Beyond the Hague
- borforismi
- Cor-pus
- Cosepercuivivere
- Crampi 2
- Der Spiegel
- Die Zeit
- Gabriella Giudici
- Get Inspired
- Get Polling
- Get Support
- I Discutibili
- International Herald Tribune
- Kip Hale on Huffington Post
- L'Espresso
- La Finestra sul cortile 2.0
- La Repubblica
- Le Monde
- Le Monde Diplomatique
- Learn WordPress.com
- Policy Lost
- Politica è Responsabilità
- Slec
- Spunti di svista
- The Guardian
- Theme Showcase
- WordPress Planet
- WordPress.com News
Commenti recenti
- Nota metodologica: per non sovraffollare il blog di miei commenti cerco di rispondere collettivamente ai commenti pervenuti, quindi ripassate a controllare le risposte.....

Questo opera è distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported.
DISCLAIMER: Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. I contenuti di questo blog rappresentano l'opinione personale dell'autore. I commenti sono di proprietà e sotto la responsabilità dei rispettivi autori e non rappresentano il punto di vista dell’autore del blog. Le immagini presenti, tranne dove diversamente specificato, sono tratte da internet, perciò si intendono di pubblico dominio. Le immagini che eventualmente risultassero ledere altrui diritti verranno prontamente rimosse a seguito di una segnalazione all'autore del blog “Senza Parole”
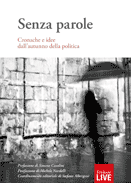
Categorie
- aforismi & citazioni (49)
- Africa (50)
- arte (8)
- Cambogia (8)
- Cina (1)
- cinema (24)
- cittadinanza (55)
- Costituzione (17)
- crimine (18)
- crisi (31)
- cultura (22)
- difesa (6)
- diplomazia (11)
- diritto (44)
- diritto penale internazionale (7)
- donne (11)
- economia (15)
- ed io (101)
- educazione (19)
- elezioni (35)
- etichetta (7)
- Europa (19)
- festività (1)
- Francia (11)
- futuro (24)
- generazioni (13)
- geopolitica (37)
- Germania (10)
- giustizia (23)
- Gran Bretagna (4)
- guerra (13)
- humanitarians (17)
- i discutibili (9)
- identità (6)
- idiozie (59)
- India (1)
- informazione (18)
- intrattenimento & spettacolo (3)
- islam (14)
- Israele (2)
- italia (120)
- legalità (24)
- letteratura (20)
- libertà (13)
- linguaggio (21)
- medio oriente (17)
- memoria (16)
- modernità (14)
- mondo digitale (19)
- morale (8)
- Nigeria (5)
- Padania (4)
- passato (7)
- politica (138)
- rapporti personali (52)
- recensioni (50)
- relativismo & fondamentalismo (9)
- religione (8)
- ricerche (175)
- Russia (5)
- scienza (3)
- scrittori sudamericani (3)
- scrittori tedeschi (2)
- sesso (8)
- sicurezza (10)
- Siria (2)
- società (48)
- solidarietà (7)
- spiritualità (4)
- sport (30)
- Stati Uniti d'America (3)
- Stato & Stati (46)
- storia & mito (22)
- Sud America (4)
- Tanzania (30)
- tempo (20)
- tolleranza (9)
- transizione (7)
- veneto (20)
- verità (11)
- viaggi (59)
- //cdnpub.websitepolicies.com/lib/cookieconsent/cookieconsent.min.jswindow.addEventListener("load", function(){window.wpcc.init({"position":"bottom","colors":{"popup":{"background":"#cff5ff","text":"#000000"},"button":{"background":"#5e99c2","text":"#ffffff","border":"transparent"}},"layout":"edgeless","content":{"href":"https://redpoz.wordpress.com/cookie-policy/","message":"L'autore del blog ignora quali cookie e dati personali questo sito raccolga (tramite wordpress o altri). In ogni caso, gli utenti sono avvisati che proseguendo la navigazione autorizzano alla raccolta e trattamento dei propri dati personali ai sensi della direttiva UE GDPR","dismiss":"Accetto"}})});
Log In
Flag Counter
Archivio post