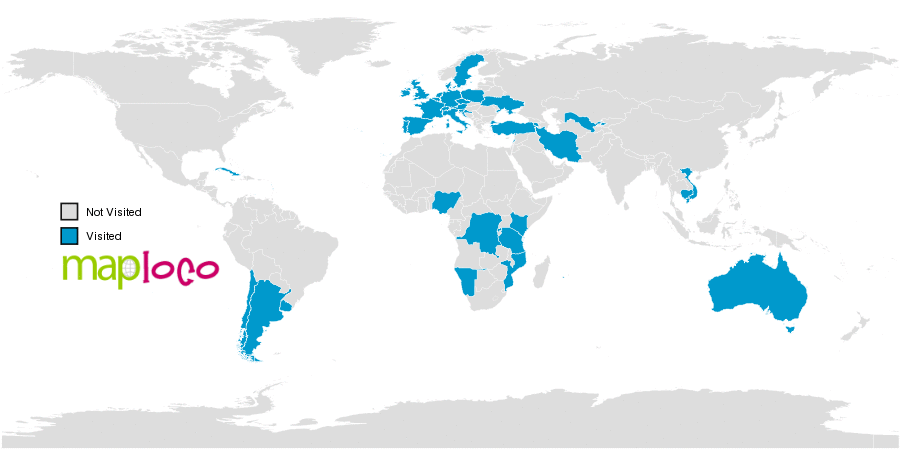Recensione 53: “La violenza e il sacro”
Premessa: Rene Girard ha senza dubbio una mente brillante, ma scrive malissimo. Forse mi sto disabituando a leggere materie complesse (?), ma per finire questo libro ho faticato enormemente (cominciato a febbraio, finito a giugno…). Se Girard avesse scritto ai giorni nostri, dubito fortemente il saggio in questione sarebbe stato pubblicato: a voler essere gentili, si potrebbe dire che lo stile e’ -per usare il metro di giudizio con cui si commentavano i miei essays al SOAS- muddy.
Seconda premessa: forse la mia ostinazione anti-religiosa e’ riprova proprio della tesi tellurica di Girard, ma non posso fare a meno di provare [feel – sentire] una certa ostilita’ verso il suo continuo riportare la questione sociale alla religione, qualcosa di profondamente reazionario (infatti, nonostante Girard riconosca all’epoca contemporanea una comprensione del fenomeno religioso/sacrificale mai raggiunta prima, e’ sempre pronto a ricordarci come questa comprensione significhi allo stesso tempo una “dimenticanza” del sacro/violenza, cui siamo condannati a ritornare).
Nonostante tutto questo, “La violenza e il sacro” e’ un testo eccezionale.
Un testo che, forse per deformazione professionale, mi ha aperto moltissime domande -alle quali probabilmente non sapro’ dare risposte, ma nondimeno terrannno viva la mia personale elaborazione.
Navigando attraverso molteplici materiali storici, antropologici, etnografici, letterali (in particolare, le tragedie greche) e filosofici, Girard mira a rivenire (scentificamente) l’origine del religioso, cioe’ -secondo il filoso francese- del sociale.
Senza addentrarmi troppo nella complessa e disparata ricerca riproposta dall’autore (una sentisi -accessibile e comprensibile- del pensiero girardiano si puo’ trovare presso il blog di Gabriella Giudici), mi limito qui a riprendere alcuni aspetti fondamentali del libro.
Secondo Girard tutti i miti, tutti i riti hanno un’origine comune: quella della violenza fondatrice, la quale per il tramite di un “capro espiatorio” [ri]costituisce un’unanimita’ violenta (tutta la comunita’ contro uno, la vittima), che pone fine alla violenza intestina (tutti contro tutti) e [ri]crea un’ordine sociale.
La prima uccisione collettiva, secondo Girard, trasporta la comunita’ dal sacro al religioso, ad un sistema ordinato, differenziato e pacifico nel quale la violenza che durante il sacro si dirige in modo indifferenziato, viene strutturata, ordinata e indirizzata verso vittime specifiche. In pratica questo momento dell’unanimita’ violenta trasforma il conflitto in pace, in un nuovo ordine sociale. Opera una catarsi della violenza da distruttrice a costruttiva.
Questa violenza fondatrice sara’ poi ripetuta in forma di riti e progressivamente strutturata e trasferita su altri oggetti secondo le forme culturalmente speficiche definite da ciascun rito. La ritualizzazione occultera’ sempre piu’ il ruolo della violenza nella societa’, la sua stessa immancabile presenza.
Fondamentale, nella ricostruzione proposta, e’ che la prima vittima sacrificale sia scelta casualmente: non e’ una qualita’ specifica della vittima ad essere rilevante, ma l’unita’ che scaturisce (senza ragione apparante) da e nella sua uccisione.
Nelle ripetizioni future e rituali dell’uccisione -come anticipato- la scelta della vittima sara’ strutturata in modo da selezionare esseri al contempo simili e dissimili dalla collettivita’ (ad esempio re, pazzi o nemici), destinati sempre al contempo ad appartenere e non appartenere alla societa’ (come l’homo sacer individuato da Agamben). Particolari riti saranno dunque dedicati a
a) rendere la vittima quanto piu’ simile (es. antropoformizzazione di animali) o dissimile dal resto della comunita’ (enfatizzazione di alcune caratteristiche peculiari),
b) nel concentrare su di essa le nefandezze (ad esempio, in alcuni riti si invitano le future vittime a commettere ogni sorta di crimini e aberrazioni).
In virtu’ di questa loro doppia natura, i futuri capri espiatori (le vittime sacrificali) sono sufficientemente simili al resto della collettivita’ dal ripetere la violenza fondatrice originaria, il suo meccanismo di fondo, ma al contempo sufficientemente distinti da questa da evitare di riaccendere conflitti intestini, (non) alimentare vendette reciproche.
Non a caso, questo capro espiatorio, secondo Girard, rispondeva nella Grecia antica, al nome di pharmakon (che come tutti ormai sappiamo significava sia veleno che cura) o katharos (da cui il concetto di catarsi).
La teoria girardiana e’ senza dubbio affascinante, nonstante la sua insistenza sul religioso come fondamento del sociale (e implicita critica alla societa’ contemporanea che se ne distacca), oltre alla parallela insistenza sulla differenza (differenziazione) come unica garanzia contro il ritorno della violenza, con conseguente critica all’uguaglianza* contemporanea. Secondo Girard, infatti, la violenza del tutti contro tutti risulta proprio dalla e nella perdita delle differenze, nella confusione di tutti con tutti.
*[ricerca della]
La qualita’ fondamentale, per me, di questa ricerca e’ il riportare la violenza al centro della societa’ umana, la costante ripetizione di come l’umanita’ cerchi un sistema per incanalare e occultare la violenza onnipresente (e, soprattutto, fondatrice).
Un grande studioso contemporano della violenza come Stathis Kalyvas ha suggerito che “all order is violence in disguise“: fino alla lettura di Girard interpretavo questa affermazione come una critica pseudo-anarchica del sistema sociale (qualqunque sistema), destinato a fossilizzare il potere di alcuni contro altri. Leggere Girard mi spinge ora a pensare che Kalyvas sia andato anche piu’ nel profondo, verso il nocciolo di una verita’: ogni ordine, altro non e’ che una violenza strutturata e occultata (fondatrice), perche’ senza questa violenza non potrebbe esservi un ordine, con conseguente conflitto tutti contro tutti. Ovvero, la massima di Kalyvas non sarebbe solo l’ennesima asserzione del fatto che ogni ordine sociale in qualche modo serve un potere / un gruppo specifico e dunque, in quanto tale, e’ una forma (strumento) di violenza strutturale (come si direbbe oggi seguendo Zizek). Bensi’, quella massima rivelerebbe proprio cio’ che secondo Girard miti e riti cercano di occultare: ogni forma di ordine si fonda su una violenza originaria. Ovvero, la violenza (non meramente strutturale, bensi’ fisica, diretta) e’ tantola molla stessa che da’ origine all’ordine sociale, quanto un rischio reale e sempre presente in ogni societa’ (come rottura dell’ordine sociale -per Girard: crisi sacrificali).
Ma le riflessioni non si fermano qui.
Che dire, allora, della giustizia di transizione, di processi di ri-costituzione di un ordine sociale tramite una catarsi politico-giudiziaria, come avvenuta (per esempio) a Norimberga, in Argentina o in Cambogia?
Non sono forse le crisi che hanno condotto a questi momenti di transizione quello che Girard definirebbe “crisi sacrificali”, ovvero il ritorno di quella violenza indifferenziata? Certo, una seppure labile differenziazione permaneva in tutti questi contesti (a mio giudizio: molto discutibile nella Kampuchea Democratica), ma la scala della violenza potrebbe ragionevolmente essere paragonata a quella situazione di conflitto di tutti contro tutti cui accennavo sopra.
Se cosi’ fosse, la giustizia di transizione non rappresenta forse un nuovo momento di “unanimita’ violenta” fondatrice, con tutte le conseguenze? Sarebbe opportuno provare ad analizzare questi processi sotto questa lente, provare a comprendere se, come e contro chi questa unanimita’ violenta si dirige. Forse, questo tipo di analisi potrebbe aiutarci a risolvere l’annosa questione fra una victor’s justice (Germania, Ruanda) e una piena truth and reconciliation (Sudafrica).