Recensione 58: “My Nazi Legacy”
Una recensione di “My nazi legacy” è un’opera complessa, vista la densità di contenuti che questo documentario propone (specie per chi, come chi scrive, può vantare un occhio privilegiato su alcune situazioni descritte con riferimento all’Ucraina).
Il documentario scritto e interpretato da Philippe Sands (con la direzione di David Evans) raccoglie in sé molte questioni che le generazioni attualmente in vita (perlomeno la nostra, quella dei nostri genitori e quella dei nostri figli) dovrebbero affrontare con riferimento al tragico passato della Shoah.
Probabilmente sono arrivato ad interessarmi a questo film seguendo una linea che dalla giustizia di transizione mi ha condotto sino alla scoperta di Sands come giurista e alla questione della trasmissione intergenerazionale del trauma (di cui non sono in grado di parlare con compiutezza, ma per la quale rinvio al buon “Lost in trasmission” di Gerard Fromm) – un campo, che non a caso, ha tratto la sua prima linfa proprio dall’analisi psichiatrica dei traumi causati dall’Olocausto, dalla prospettiva delle vittime e dei loro discendenti.
Anche Sands parte dalla stessa linea, ma nel documentario arriva brillantemente a rivoltarla e focalizzare la lente sui carnefici, anzi: sui loro figli e ad affrontare la loro (altrettanto, se non di più) complessa relazione coi propri padri genocidiari e le azioni di questi. Nato da ebrei ucraini della regione di Leopoli emigrati prima in Francia, poi in Inghilterra, egli è divenuto un reputato giurista internazionale (legale del Gambia nel caso sui Rohynga), autore di saggi sui diritti umani ed opinionista giuridico per alcuni quotidiani inglesi. Ad un certo punto della propria vita, Sands ha deciso di provare a ripercorrere a ritroso la strada che portò i suoi antenati in Inghilterra, di provare a squarciare i silenzi che circondavano la sua famiglia e a scoprirne l’origine, la sofferenza, sino a tornare a Leopoli e alle fosse comuni.
Partendo dalla propria storia familiare e personale, Sands rintraccia i figli dei comandanti nazisti che ordinarono, orchestrarono ed eseguirono lo sterminio degli ebrei nell’Ucraina occidentale e apre un intenso, sofferto dialogo con loro.
Da questo viaggio ne è poi partito un altro, descritto in “My nazi legacy” e nel libro “The ratline“, un viaggio parallelo che vuole re-intersecare le storie non solo di individui (i genitori o nonni), ma più generazioni.
Il giurista si trova quindi a incontrare e dialogare con i figli di due comandanti nazisti: Niklas Frank (figlio di Hans Frank, governatore della Polonia occupata) e Horst Arthur Wächter (figlio di Otto Wächter, governatore della Galizia). Assieme a loro ripercorre alcune tappe delle rispettive giovinezze fra Germania, Polonia e Leopoli, fra i campi delle fosse comuni, fra le sinagoghe bruciate e i palazzi del potere nazista, indagando il rapporto coi padri, la memoria, la relazione con l’Olocausto.
Vi siete mai chiesti cosa debba pensare del padre il figlio di Eichmann? Ecco, Sands prova a darvi risposta.
Se per lungo tempo la domanda rivolta ai genitori è stata voi cosa avete fatto [per combattere il nazismo]?, col passare delle generazioni comincia ora ad aprirsene un’altra: come vedi tuo padre?
Se Eichmann (e, come lui, tanti ufficiali responsabili del genocidio degli ebrei come Frank e Wächter) incarnava la “banalità del male”, il genitore che durante il giorno fucila decine di ebrei e la sera gioca coi bambini mentre Beethoven suona in sottofondo, cosa incarnano i loro figli? Che rapporto personale, intimo possono avere col padre? Che memoria? E che rapporto storico? E i due piani si distinguono?
Nelle parole di Sands: what would I do if my father was a mass murderer? Would I love him? Would I hate him? Would I be Niklas or Horst? Those questions transcend the Holocaust, so it’s not a film about Nazis and Jews.
Credo nessuno di noi sarebbe in grado di rispondere a simili domande, in astratto (e forse anche in concreto: da qui spazio per il trauma psichico).
Ovviamente due storie non possono rispondere in modo generale a queste domande, ma ne aprono uno squarcio estremamente interessante.
Troviamo quindi genitori freddi e distaccati (l’unico gesto d’affetto che Niklas Frank ricorda dal padre è una carezza di questo mentre si rade), ma colti ed amanti dell’arte. Troviamo figli che arrivano ad esprimere un vero e proprio odio verso il padre (molto interessanti a riguardo gli aneddoti riportati dal regista sulla richiesta di Niklas rappresentare il padre in una luce più negativa di quanto inizialmente fatto). Ma troviamo anche chi come Wätcher nega allo stremo le responsabilità del genitore, nega di fronte ai discorsi, nega di fronte agli ordini, nega di fronte alle fosse comuni. Lasciando che l’amore filiale mantenga il sopravvento sulla repulsione, oppure non provandone alcuna.
Nella campagna ucraina si apre poi uno scorcio del presente, l’indagine storica-familiare si interseca con la quotidianità e la memoria collettiva: in una tappa del viaggio i tre (Sands, Frank e Wätcher) incontrano il funerale di alcuni volontari ucraini della Divisione SS Galizia durante la Seconda Guerra Mondiale (resoconto e foto dell’incontro qui). Il nazionalismo ucraino contemporaneo celebra questi collaboratori in opposizione all’occupazione sovietica e all’influenza russa dei giorni nostri, sminuendone i crimini anche a costo (o forse proprio con l’intento) di apparentarsi e presentarsi come neonazisti. Wätcher, una volta presentato, viene celebrato proprio in quanto figlio del comandante nazista. E si sente rincuorato dall’affetto che gli ucraini mostrano verso il padre, affetto che lo rinforza nella propria convinzione che questi fosse in fondo una brava persona, un uomo buono. Pura benzina per il revisionismo.
Come commenta Bradshaw: It becomes disturbingly clear that although Frank Jr has come to terms with what his father did, Wächter Jr is still in denial – wriggling, squirming, trying to claim that his father was not personally guilty.
Queste reazioni disturbano lo spettatore. E, evidentemente, disturbano Sands, che a più riprese prova a porre in dubbio le certezze di Wätcher, ponendolo di fronte agli ordini impartiti, alle conseguenze di quegli ordini – toccante il momento in cui Sands contempla i campi, voltando le spalle a Frank e Wätcher.
Un film denso, densissimo di prospettive e contenuti, neppure interamente sviscerabili dalla camera. Un film personale e collettivo, toccante. Un film altamente raccomandato, che al termine dovrebbe motivarvi a leggere qualcuno dei libri di Sands.


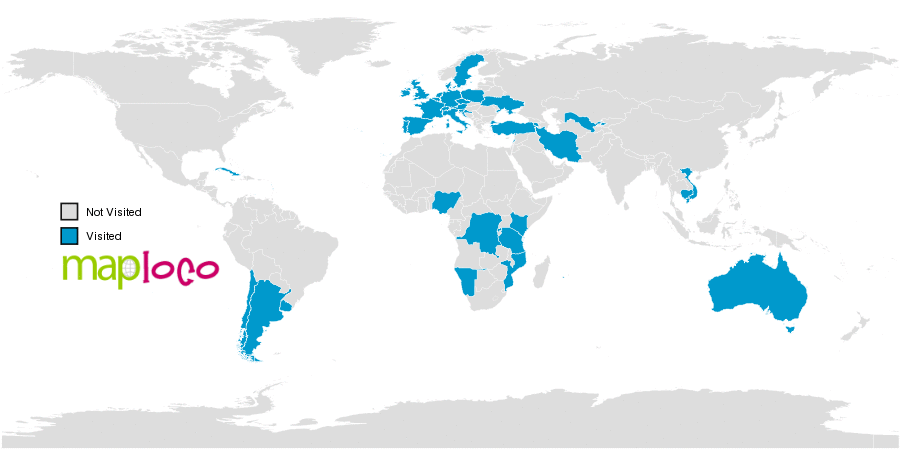


Non posso esprimermi in merito perché non ho visto il film, ma le sue premesse mi hanno fatto venire in mente una domanda sulla “cultura della vittima” di cui hanno parlato i Wu Ming: se in qualche modo riconosciamo ai “figli” delle vittime un qualche tipo di “diritto” sulle sofferenze che i padri patirono, allora perché non accusiamo i figli delle colpe dei padri? Più in pratica: se diciamo che i figli dei “martiri” delle foibe (e prescindiamo per un momento dalle ridicole invenzioni su questo tema) meritano di poter dire la loro sull’esodo istriano, allora perché non vietiamo alla Mussolini di stare in politica? Non so se mi sono spiegato.
Bella domanda! Cui, ovviamente, non ho risposta.
Forse perché riguardo l’esser vittime abbiamo una maggiore consapevolezza? Perché esiste un minimo di letteratura (psicologica, socio-economica, filosofico-giuridica) che identifica qualche collegamento fra le sofferenze dei padri e quelle dei figli, una qualche “causalità”? (Se ai genitori sono stati espropriati tutti beni, è evidentemente più probabile che anche i figli siano poveri; se i genitori hanno vissuto traumi, è probabile che li passino ai figli)
O forse semplicemente perché seguiamo una certa visione del tempo? Forse perché partiamo dal presupposto che tutti si nasca “senza colpe” (secolari)?
Però, venendo all’esempio concreto, credo occorra raffinarlo un pò: troveremo giusto impedire alla Mussolini di fare politica tout court? Personalmente, avrei qualche difficoltà. Sarei invece interamente d’accordo se si volesse impedirle di fare politica fascista (a lei, come probabilmente a chiunque altro). Ma allora il divieto deriva dalla genealogia biologica o da quella ideologica?
Ma infatti il problema non è che la Mussolini faccia politica: è che faccia politica mentre si riconosce che i figli (o addirittura i nipoti) degli “esuli” debbano essere trattati con maggior rispetto degli altri.
Non avevo compreso il senso del primo commento.
Ma allora il problema non è se i discendenti degli esuli istriani debbano essere “trattati con maggiore rispetto” in astratto, ma se per il sentire sociale esistano ragioni che giustificano questo trattamento differenziato. Probabilmente tu, io e Wu Ming sosteremmo di no; altri di sì. Dovremmo cominciare individuando quali sono i criteri di giudizio: esistono comprovati danni economici (nel frattempo non mitigati)? esistono indicazioni di trauma trans-generazionale? etc
Però a quel punto dovremmo anche chiederci: dovremmo requisire i beni della Mussolini?
Non conosco affatto la fonte di quei beni per esprimere un giudizio… In ogni caso, oggi mi parrebbe una soluzione non adeguata. All’epoca, molto probabilmente sì.
Ma la giustizia di transizione non è una scienza esatta