Recensione 62: “Il Paradosso della Bontà”
Da alcuni anni mi sono affidato a Corrado Augias come segnalatore di libri “che meritano di esser letti”, per la precisione (se non erro) da quando raccomando’ questo: una lettura intelligente, educativa, affascinante e gradevole. Mix perfetto.
Saldo su questa coscienza, quando Augias ha recensito e bollato come meritevole “Il paradosso della bontà‘” di Richard Wrangham, ho provveduto a procurarmelo e leggerlo il prima possibile.
Il libro aveva tutte le premesse per rivelarsi una lettura memorabile o quasi (come -sempre su avviso di Augias- fu “La lingua colora il mondo“). Tendenzialmente sarebbe bastato il tema a convincermi: la violenza. Purtrppo, su questo tema persino chi lo tratta professionalmente e con cognizione di causa spesso scrive boiate. La cautela era quindi d’obbligo.
Wrangham si pone una domanda di enorme importanza: perche’ l’uomo e’ allo stesso tempo altamente socievole e pacifico e altamente violento? E prova a darvi risposta mettendo a disposizione e collegando assieme una vasta mole di materiali, per lo piu’ ancora non accessibili al grande pubblico (ovvero: lettteratura ancora scientifica e specialistica), materiali che spaziano dalla psicologia, all’archeologia, all’antropologia e alla biologia.
Con tutto questo materiale a disposizione, l’antropologo e primatologo inglese riesce a proporre una risposta articolata e per lo piu’ convincente. Risposta che, dato il suo background professionale (lo studio di scimpanze’ e bonobo), Wrangham approfondisce nel confronto coi primati a noi piu’ simili.
Secondo l’autore, infatti, gli essere umani beneficerebbero di una bassa aggressività reattiva, ma di un’alta aggressività proattiva (in confronto ai primati, ma anche rispetto ad altre specie animali). Distinzione, quella fra le due tipologie di aggressività a lungo sconosciuta e non analizzata.
Secondo Wrangham, in estrema sintesi, l’essere umano e’ meno propenso a regire violentemente quando provocato (aggressitivà reattiva), ma piu’ propenso a pianificare “a mente fredda” atti violenti (aggressività proattiva).
Dato questo per appurato (su basi che non sto a ripetere), seguendo un modello adattivo (darwiniano) Wrangham si dedica dunque a ricercare le cause dei diversi livelli di aggressività.
Nella seconda parte del libro, quella dedicata all’aggressività reattiva, effettivamente le prove a disposizione appaiono fortemente convincenti (magnifico lo studio sulle volpi di Belyaev): l’uomo si sarebbe addomesticato. Ovvero, in un processo millenario, agli individi piu’ violenti sarebbe stato impedito di riprodursi, favorendo la proliferazione di tratti meno aggressivi. I dati biologici (prima ancora che psicologici) a supporto della tesi sono stupefacenti (non solo per l’uomo, ma per molte altre specie).
Posto che nessun essere terzo ha addomesticato l’uomo, si pone dunque la questione di come questo processo sia potuto avvenire.
La risposta che Wrangham propone e’ che si sarebbe trattato di un processo di auto-addomesticazione, nel quale gli stessi esseri umani avrebbero progressivamente (specie all’epoca dei primi homo sapiens) eliminato violentemente gli individui (alfa) piu’ aggressivi. A contrario di bonobo e scimpanze’, questo processo sarebbe stato possibile per l’uomo grazie ad un “semplice” fattore: il linguaggio.
Il linguaggio avrebbe consentito all’uomo preistorico di organizzare coalizioni, di programmare l’uccisione di un individuo da parte di un gruppo, il quale in virtu’ del numero soverchiante, avrebbe avuto una forza schiacciante e non avrebbe dovuto temere sconfitta o danno.
Questo passaggio costituisce il trait d’union che lega la bassa violenza reattiva con l’alta violenza proattiva.
Scoperto questo “potere” coalizionario del linguaggio ed i vantaggi “militareschi” che ne derivano, l’aggressività proattiva sarebbe divenuta ancora piu’ importante per l’essere umano che non per altri animali (primati inclusi).
La teoria, seppure affascinante e relativamente fondata (o, perlomeno, credibile e plausibile), a mio avviso qui comincia a vacillare un po’. L’autore riconosce che le prove, soprattutto per questo passaggio, sono assai incerte e richiedono ulteriori ricerche (mentre, azzardei, per la domesticazione vi sono elementi piuttosto forti), tuttavia ho avuto l’impressione che, ad eccezione della logica, nessun argomento portato da Wrangham si riveli di per se’ piu’ probabile delle teorie alternative che egli passa in rassegna per confutarle. V’e’, nel compesso, una varietà di possibili spiegazioni, di fattori relativamente persuasivi, che la fermezza del ragionamento vacilla un po’.
Wrangham commette qui, a mio avviso, l’errore di fidarsi un po’ troppo della propria teoria e volerne spingere la validità tramite argomenti logici fino al suo limite ultimo. La logica regge, ma appare un elemento troppo debole.
Egli arriva cosi’ ad affrontare una molteplicità di ambili scientifici assai vasta (specie sul tema della guerra), del quale forse non ha una conoscenza e una compresione altrettanto approfondita come nel proprio campo, e a respingere teorie potenzialmente meritevoli (e magari complementari).
In ultima, avrei trovato il libro piu’ convincente se si fosse fermato un passo prima; a volte piu’ leggibile se i rimandi interdisciplinari fossero stati piu’ contenuti. Nel complesso, resta un testo affascinante per chi voglia approfondire da una prospettiva nuova e diversa il tema della violenza.


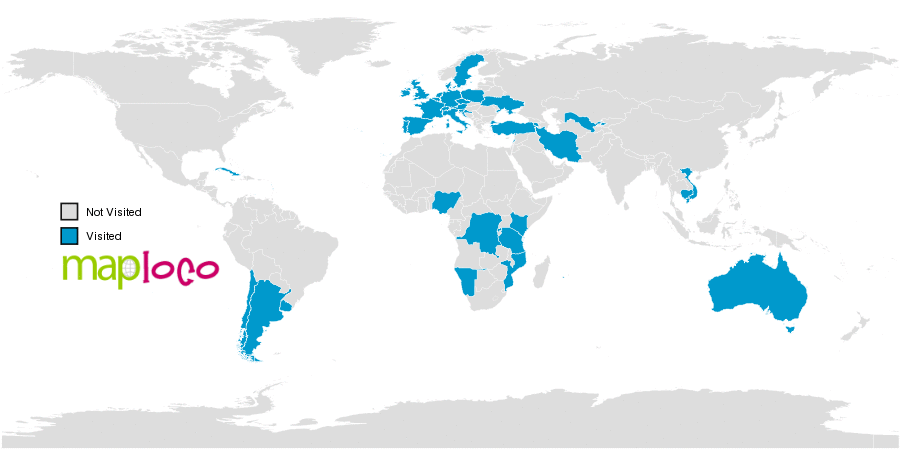


Grazie della segnalazione.