Recensioni 51 e 52: “Storia Naturale della Distruzione” e “Congo”
Recensione 51: “Storia Naturale della Distruzione“
Sono stato inizialmente spinto a leggere questo libro perché citato da una di quelle persone che vorrei poter chiamare ‘Maestro‘ (ma questo non diteglielo) e per rispetto mi astengo tuttora dall’azzardami. Una di quelle persone capaci di fondere assieme analisi socio-economica e Sciascia (senza dimenticare Foucault, Marquez e ovviamente Sebald). E’ già il secondo libro che questa persona mi ‘regala’ (come suggerimento) e di nuovo è stata una lettura profondamente affascinante e istruttiva.
Nota sulla traduzione del titolo, l’originale tedesco e’ “Guerra aerea e letteratura“, e per quanto la traduzione (sia inglese che italiana) sia accattivante, mi pare in qualche modo fuorviante.
Il libro dello scrittore tedesco (ma trasferitosi da anni in Inghilterra) Georg Sebald è in ogni caso un piccolo capolavoro di analisi storica, psicologica e letteraria. Forse una delle più profonde riflessioni sulla psicologia tedesca dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi.

Amburgo 1943
Tutti oggi ricordiamo Dresda, ma quasi nessuno pensa che quei bombardamenti hanno colpito praticamente tutte le città tedesche (inclusa Amburgo: nome in codice “Operazione Gomorrah“, sic). Tutti vediamo le foto dei palazzi rasi al suolo, ma pochi di noi riescono nel pensiero successivo che in quei palazzi vivevano centinaia di persone, uccise dalle bombe. E ancora meno riescono a pensare a quale atroce morte devono aver avuto quelle persone. Sebald ci consegna alcune descrizioni: al contempo troppe per il nostro stomaco e troppe poche per la doverosa memoria.
 Alla luce di questi fatti, la domanda fondamentale che Sebald si pone in “Storia Naturale della Distruzione” è tanto semplice quanto disarmante: perché nella letteratura postbellica tedesca non si trovano riferimenti riguardo l’immane distruzione che la Germania ha sofferto a causa della guerra aerea fatta di bombardamenti a tappeto e bombe incendiarie portata avanti dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti contro le città tedesche? Perché di questa enorme devastazione non si trova traccia nelle opere degli scrittori tedeschi? E perché, in quelle poche voci che ne parlano, il tono rimane sempre irrimediabilmente una brutta copia della retorica e della metafisica nazionalsocialiste?
Alla luce di questi fatti, la domanda fondamentale che Sebald si pone in “Storia Naturale della Distruzione” è tanto semplice quanto disarmante: perché nella letteratura postbellica tedesca non si trovano riferimenti riguardo l’immane distruzione che la Germania ha sofferto a causa della guerra aerea fatta di bombardamenti a tappeto e bombe incendiarie portata avanti dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti contro le città tedesche? Perché di questa enorme devastazione non si trova traccia nelle opere degli scrittori tedeschi? E perché, in quelle poche voci che ne parlano, il tono rimane sempre irrimediabilmente una brutta copia della retorica e della metafisica nazionalsocialiste?
La risposta di Sebald alla prima domanda si compone di due elementi, entrambi cruciali: innanzitutto, Sebald rileva come quell’atroce distruzione sia sostanzialmente incomunicabile (forse persino incomprensibile). Come si può descrivere l’orrore di una realtà che supera la fantasia? Come si può parlare dei cadaveri delle persone bruciate vive a centinaia nei rifugi antiaerei? Mi perdonerete se azzardo il riferimento ad Auschwitz: come si può parlare di questo orrore senza scadere nella retorica? Non a caso, scrive Sebald, forse le uniche cose decenti scritte sulla distruzione delle città tedesche durante la Seconda Guerra Mondiale sono i reports medici delle autopsie.
Ma, in secondo luogo, come può la memoria di questo orrore accordarsi con “il boom economico”, con la ricostruzione? Come si può permettere al ricordo di ancorarci ad un passato tanto terribile e shoccante mentre tutto attorno a noi ci impone di andare avanti?
Appare evidente come un simile trauma come quello sofferto coi bombardamenti (testimonianze storiche riportano di donne sfollate che viaggiavano coi loro bambini carbonizzati in valigia) non potesse essere compatibile con l’imperativo della ricostruzione, del lasciarsi tutto alle spalle (crimini & sofferenze assieme).
Non sono del tutto sicuro invece che Sebald riesca a rispondere alla seconda domanda, ma (anche alla luce dei limiti rilevati rispondendo alla prima) credo il merito maggiore sia proprio il riuscire a porre in evidenza questa terribile continuità.
Per me, che non conoscevo Sebald prima di questo libro, è stata una scoperta preziosa. Non solo un’analisi fine e profonda, ma altresì (spero) il primo passo in un lungo viaggio in compagnia di un nuovo autore potenzialmente destinato ad accompagnarmi per parecchio tempo. Ma che peccato Sebald ci abbia lasciati dopo un solo libro non-fiction.
Recensione 52: “Congo“
Molto più difficile, per me, un parere su “Congo” di David Van Reybrouck. Il giudizio mi riesce soggettivamente difficile non perché quello di van Reybrouck sia un cattivo libro, anzi, ma per due ragioni concorrenti: tutto l’hype che ve n’è stato fatto attorno (basti citare la recensione di Saviano riportata in quarta di copertina: “Dimenticate tutto ciò che sapete dell’Africa, tutti gli stereotipi, i luoghi comuni e tuffatevi in questo libro. Che è un’opera gigante“) e il fatto che (a causa dei miei ultimi studi al SOAS), molte delle cose riportate in “Congo” già le conoscevo.
Ciò non toglie che questo sia un libro eccezionale, un piccolo colosso  (600 pagine, ma ciò va detto a merito dell’autore: con tutto il materiale analizzato, avrebbero benissimo potuto essere più del doppio), rispetto al quale ogni giudizio men che positivo sarebbe un’ingiustizia.
(600 pagine, ma ciò va detto a merito dell’autore: con tutto il materiale analizzato, avrebbero benissimo potuto essere più del doppio), rispetto al quale ogni giudizio men che positivo sarebbe un’ingiustizia.
“Congo” è (o dovrebbe essere), senza dubbio, una tappa obbligata per chiunque voglia parlare di Africa. In queste 600 pagine, van Reybrouck riesce nell’opera immane di sintetizzare la storia di uno dei più grandi e complessi Stati africani. Riesce a riportare dati minuziosi e testimonianze disparate. Forse tutto questo era già disponibile altrove, ma riuscire a sistematizzarlo in un’opera accessibile anche a lettore più ignorante degli affari congolesi è un risultato non da poco. Tutto o quasi: a van Reybrouck va inoltre il -già di per sé enorme- merito di integrare la ricerca storica con testimonianze “antropologiche” disparate fra decine e decine di attori congolesi, di dare voce a decine di protagonisti e riportare le loro testimonianze.
Non solo l’analisi si dipana (nei dettagli) in oltre 200 anni di storia congolese, dall’inizio della colonizzazione belga sotto Leopoldo II alla Seconda Guerra del Congo, ma altresì van Reybrouck riesce costantemente a legare la storia del Congo con la storia globale, ricordandoci come le alterne sorti di questo enorme paese siano sempre state legate agli avvenimenti mondiali (la crescita del prezzo del rame durante la guerra in Vietnam, per esempio, che consentì l’affermazione di Mobuto; ma anche il contributo dei soldati congolesi durante le guerre mondiali… specie contro la colonia italiana in Etiopia). E, in definitiva, ricordandoci come tanta della responsabilita’ per le condizioni di milioni di persone nel continente africano dipendano (anche) da noi. E non solo per via della colonizzazione.
Lo stile non è quello iper-analitico di un testo scientifico, ma un mix che riesce a catturare il lettore quasi nella narrativa, sempre tuttavia saldamente ancorata alla realtà e ai dati. Tuttavia, a volte questo sforzo di van Reybrouck nel narrare mi è parso un pò forzato e forse troppo emozionale.
Inoltre, forse proprio grazie alle molte testimonianze, “Congo” non è un reportage sulle sciagure di un popolo o la voce della disperazione, bensì un mosaico equilibrato fra la tragedia e la speranza.
Come tutti i libri, anche quello di van Reybrouck contiene una serie di giudizi ed opinioni, rispetto ai quali si può non essere d’accordo (si pensi in particolare ai pareri sulla classe politica congolese, specie ai tempi dell’indipendenza). Ma si tratta sempre di giudizi ben articolati e contestualizzati.
Dobbiamo provare un giudizio? Se avete un master in cooperazione allo sviluppo, economia politica o war studies in Africa, potete risparmiarvi “Congo“. Altrimenti, conviene procurarselo.
Dopo, guardatevi Anthony Bourdain.
9 thoughts on “Recensioni 51 e 52: “Storia Naturale della Distruzione” e “Congo””
Lascia un commento Cancella risposta
Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.


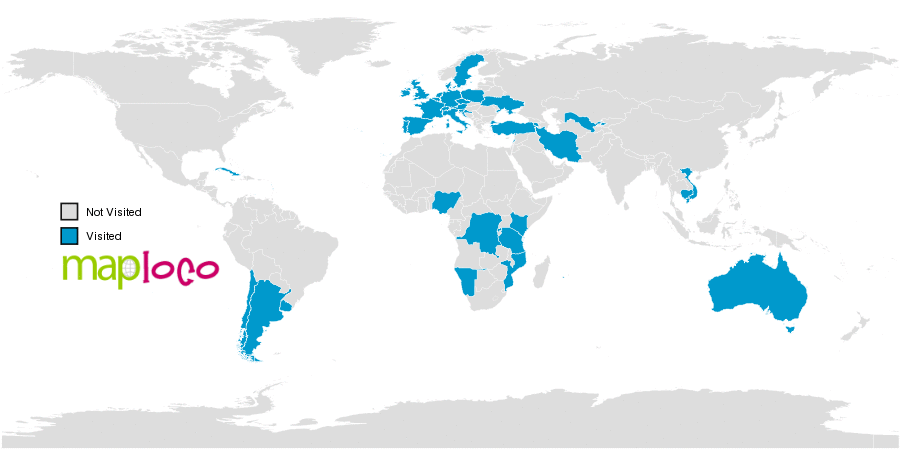


È stato inevitabile, leggendo del bombardamento di Dresda, non pensare a “Mattatoio numero 5” di Vonnegut, a quel ragazzo che era partito per l’Europa convinto di tornare da eroe e che, invece, si rese conto lì che la guerra era solo un modo più raffinato di chiamare una strage. Forse è questo il punto: persone cresciute nella retorica del nazionalsocialismo, come potevano raccontare qualcosa del genere?
Premetto che non ho letto Vonnegut.
Domanda interessante, cui ovviamente non sono in grado di dare una risposta compiuta. Tuttavia, prendendo anche spunto da Girard, sarei orientato per una risposta affermativa. O, meglio, una risposta affermativa e negativa al contempo (in astratto e in concreto?). Affermativa nel senso che (secondo me) pure persone cresciute nella retorica del nazionalsocialismo (che pure non poteva aver cambiato radicalmente in appena 12 anni la mentalita’ di tutte le persone gia’ formatesi, cioe’ -a spanne- tutti coloro nati prima del 1910, scrittori inclusi) avrebbero dovuto essere in grado di descrivere una tragedia che li coinvolgeva tanto da vicino. Ma negativa (in concreto) proprio perche’ come argomenta Sebald, quella tragedia era troppo grande perche’ e troppo vicina (oltre che troppo in conflitto col futuro che stavano costruendo) perche’ essi stessi riuscissero a metabolizzarla.
Sarebbe interessante, da questo punto di vista, un confronto con la letteratura ebraica del secondo dopoguerra.
C’è anche da dire che lo stesso Vonnegut (che ti consiglio) è riuscito a parlare di quell’evento solo “travestendolo”, ed inserendolo in un romanzo di fantascienza. Che tu sappia, qualcuno degli autori tedeschi del secondo dopoguerra ha tentato un’operazione simile? Ed aggiungo: qualche autore ebraico, ha provato a fare lo stesso con la Shoah?
Sugli autori ebraici mi taccio completamente, perche’ non ne ho la benche’ minima idea. Riguardo i tedeschi, tutto quel che posso dire e’ che nel libro di Sebald (scritto nel 1999 come somma di conferenze tenute alcuni anni prima), non risulta nulla del genere.
Anche questo sarebbe un tema assai interessante per un indagine letteraria…. purtroppo non conosco quasi nessuno in questo campo, ma quasi quasi provo a fare un paio di telefonate.
Fammi sapere.
Pingback: Letteratura, memoria e psicopatia | redpoz
Pingback: Humanitarians: enough, cynicism | redpoz
Pingback: The big C (1) | redpoz
Pingback: The big C (3) – Congo 1.01 o 1.02 | redpoz